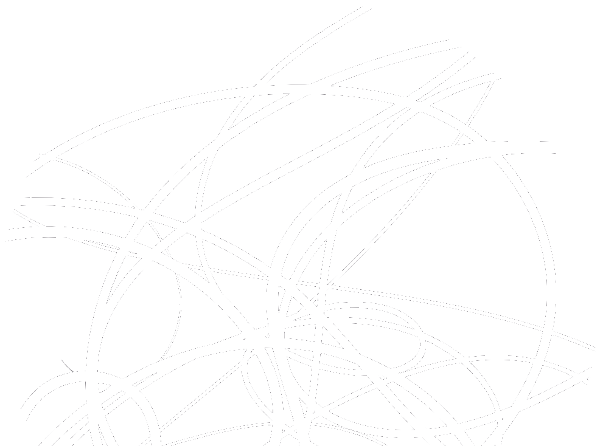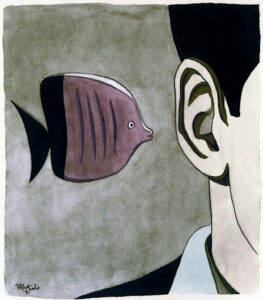Il buono storico assomiglia all’orco della fiaba: là dove fiuta carne umana, là sa che è la sua preda.
Marc Bloch, Apologia della storia. O mestiere di storico[1]
Dopo aver scritto le pagine che seguono ho provato un senso di inquietudine profonda verso me stessa. Responsabilità storica e cittadinanza inclusiva sono valori che non bastano a giustificare anni di lavoro con i giovani migranti per accompagnarli alla richiesta d’asilo. Non so perché ho rimosso Marc Bloch dalle tante riletture di questi mesi, anche se Apologia della storia sta sempre sul mio tavolo. Non è facile, in contesti tanto drammatici come quelli delle migrazioni, ammettere un sentimento tanto urgente e vitale come il desiderio e l’istinto di conoscere e capire. Ma sta sicuramente alla base dei miei dialoghi con loro.
Dialoghi
«Dal 2012 non riesco a pensare che alle vostre storie.»
«Tu hai paura che la storia si ripeta. Vorresti un mondo senza discriminazioni e ti preoccupi che succeda a noi quello che è successo durante la seconda guerra mondiale, che nasca di nuovo l’odio, il razzismo, la violenza. Ti preoccupi di questo più di quanto ce ne preoccupiamo noi … se non mi avessero rinnovato il permesso di soggiorno io forse me la sarei cavata in qualche modo, ma tu l’avresti presa malissimo. Mi sentivo responsabile anche di te.»
Yahya è senegalese, ha 27 anni, è arrivato in Italia durante la guerra in Libia, fa il mediatore culturale e da allievo di italiano per me è diventato interlocutore costante, coscienza critica, crocevia di reti.
Mi incalza: «Forse dovresti chiederti chi sei tu che studi la storia degli altri; dovresti spiegare perché lo fai.»
Lo stesso interrogativo mi era stato posto tanti anni fa da Giuliana Tedeschi,[2] che mi aiutava a trovare tracce di Luisa Levi, mia concittadina ebrea deportata adolescente ad Auschwitz col suo stesso convoglio, nell’aprile del 1944: «Lei non è ebrea» aveva osservato «Si è chiesta perché sta dedicando tanto tempo alla storia di questa ragazzina?» Mi guardava attenta, in attesa della risposta a una domanda che ancora non avevo fatto esplicitamente a me stessa. L’oggetto della ricerca si faceva soggetto: il corpo, lo sguardo, la voce di Giuliana – viva, presente, acuta – mi costringevano a fare i conti con un passato familiare che dettava i passi del mio lavoro senza che ne fossi ancora consapevole. Poi la ricerca, gli archivi, la scrittura avevano ristabilito una distanza che mi consentiva di formulare nuove ipotesi sulla storia della famiglia Levi, di interrogare nuove fonti e tentare di stabilire verità fattuali. Perché comunque il periodo della persecuzione contro gli ebrei poteva essere studiato, pur attraverso la lente coinvolgente delle singole vite, come altro da me.
Oggi è diverso: l’altro che viene da lontano è presenza fisica, interlocuzione intellettuale, coinvolgimento politico ed emotivo che porta nella mia vita continue «folate di crisi»[3] e un continuo riaggiustamento dei nessi fra pensiero, azione ed emozione. Qualcosa che costringe i cittadini europei che decidono di mettersi in relazione con lo straniero a condividere in qualche modo il confine della doppia assenza[4]: quella dalla realtà sociale e culturale nella quale siamo nati e cresciuti e quella dalla realtà emotiva, politica, storica e culturale di chi viene da realtà lontane dall’Europa e porta sentimenti e risentimenti nati anche dal colonialismo e dallo sfruttamento postcoloniale.
Il confine tra storia e presente è sottile e ambiguo. Se, rispetto al passato, da un lato oggi posso dire «non sono questo», dall’altro sono «determinata da ciò che denego».[5] Entrambi questi versanti del rapporto con la storia compaiono in uno scritto di Renate Siebert che mi è molto caro: Non dimenticare. Frammenti di una tradizione «negativa»[6]. L’autrice riflette su come la sua formazione intellettuale e politica sia stata segnata dall’essere nata nel 1942 in Germania, da una famiglia di tedeschi ‘normali’ che dopo la guerra hanno cercato di rimuovere il passato nazista. Racconta come la sua generazione di studenti dell’Università di Francoforte, negli anni che hanno preceduto il ’68, abbia preteso di sapere e si sia ribellata a quanto veniva scoprendo. Poi la tesi su Franz Fanon con Theodor Adorno, la «tendenza alla fuga» dalla Germania, la vita in Italia. E la scoperta che nel nostro Paese, più ancora che in Germania, i conti col passato non sono stati fatti. La seconda parte dell’articolo si sviluppa infatti attorno alla vicenda del documentario «Fascist Legacy» sui crimini di guerra italiani nei Balcani e in Etiopia. Prodotto nel 1989 dalla BBC, suscitò forti reazioni del governo italiano, venne acquistato dalla Rai che non lo mandò in onda e da La7 che nel 2004 ne trasmise degli stralci; a parte questo evento, fu visto solo in circuiti privati.[7]
La mia generazione nel ‘68 poco si interrogò sull’antisemitismo italiano e sui ‘nostri’ crimini coloniali. Per me fu fonte di conflitti interiori e familiari avere un padre, peraltro molto amato, che, diciottenne, aderì alla Repubblica sociale italiana. Coscienze scisse, autoassoluzioni, incapacità di cogliere la portata storica complessiva degli eventi a cui siamo contemporanei. «Determinata da ciò che denego», non ho potuto che cercare di assumermi la responsabilità storica di essere un’italiana nata dopo la seconda guerra mondiale e tentare di conoscere e far conoscere gli errori che la generazione che mi ha preceduto ha commesso. Non per senso di colpa ma perché: «L’idea di debito è inseparabile da quella di eredità»[8] e il dilemma che oggi dovrebbe continuare a interrogarci, dopo quanto è accaduto durante la seconda guerra mondiale, è «Essere presenti e contemporaneamente non esserci, l’orribile segreto degli uomini di questo secolo»[9]
Qui, altrove, oggi
Nel 2011 l’arrivo nella mia città di alcune decine di richiedenti asilo -141, tra i quali due sole donne- provenienti dalla Libia in guerra ha indotto il mio sguardo a focalizzarsi sui migranti forzati, oggetto da un lato di ostilità e rifiuto e dall’altro di una benevola, ma spesso miope e disinformata, accoglienza.
La cosiddetta Primavera araba stava conducendo Gheddafi e il suo regime alla fine e la violenta guerra civile aveva portato sulle nostre coste un consistente numero di persone dell’Africa subsahariana che vivevano in Libia: 60692 nel 2011 e 13267 l’anno successivo. Nel mese di gennaio erano giunte via mare a Lampedusa circa 5000 persone provenienti per lo più dalla Tunisia. Sapevo molto poco dell’Africa subsahariana e della Libia.
Il 12 agosto 2011 il quotidiano «Il Foglio» scriveva in prima pagina: «Gheddafi usa i clandestini come un’arma: alcuni sarebbero stati costretti a salire sulle bagnarole del mare. La “bomba” umana dei clandestini è l’arma di pressione più forte in mano al colonnello Gheddafi nei confronti dell’Europa e per prima dell’Italia».
La «bomba umana dei clandestini», per usare questo discutibile lessico, numericamente non era poi una gran cosa se si pensa che dalla Libia 790000 lavoratori migranti attraversarono invece i confini dirigendosi in massa verso altri stati africani. Appena il 3,9% di loro sbarcò sulle coste di Malta e dell’Italia. Ma l’uso di queste persone come strumento di pressione o ritorsione politica ha una storia e purtroppo un presente.
Il 30 agosto 2008 tra i due Paesi viene firmato un nuovo accordo, il «Trattato di amicizia partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la grande Giamahiria araba libica popolare socialista», per chiudere definitivamente il doloroso «capitolo del passato coloniale». Risarcimenti in denaro per i danni provocati dalla colonizzazione in cambio della tutela degli interessi economici di entrambe le parti: quelli italiani legati all’approvvigionamento di petrolio, con la presenza dell’Eni in Libia, e quelli di Gheddafi che aveva investito nelle azioni di imprese italiane come Fiat e Unicredit. Con questo accordo l’Italia si impegnava a versare alla Libia cinque miliardi di dollari in vent’anni per realizzare progetti e infrastrutture affidati a imprese italiane con fondi gestiti direttamente dall’Italia. Ma un punto saliente dell’accordo era la lotta all’immigrazione, che verrà dispiegata con un sistema di controllo delle frontiere terrestri della Libia, «da affidare a società italiane in possesso delle necessarie competenze tecnologiche» e i cui costi dovevano essere sostenuti al 50 per cento dal governo italiano e per il restante 50 per cento dall’Unione Europea.[10]
Poi, nel 2011, l’Italia partecipa all’operazione militare Odyssey Dawn a sostegno degli insorti contro Gheddafi, mette a disposizione delle forze sotto mandato ONU sette basi militari e otto aerei. L’ambasciata italiana a Tripoli viene chiusa.
Chiedere asilo, mostrare ferite
Nel 2011, il governo dichiara lo stato di emergenza umanitaria, l’Emergenza Nord Africa (ENA). Albergatori e grosse cooperative che accolgono i profughi riescono ad avere buoni guadagni sui 46 euro al giorno che a quel tempo venivano assegnati ai gestori dei centri d’accoglienza per ogni richiedente asilo; ma intorno ai rifugiati non c’è solo speculazione; ci sono talvolta anche istituzioni e cittadini di buona volontà che si impegnano in attività di «integrazione» e in iniziative che favoriscono la conoscenza delle persone arrivate dalla Libia. Capita che i «ragazzi» vengano invitati a narrare in pubblico le loro storie. Storie che, dovendo fare richiesta d’asilo, avevano già dovuto raccontare, sottolineandone tutta la drammaticità, anche durante le audizioni davanti alle Commissioni territoriali e ai Tribunali cui spettava concedere qualche forma di protezione.
Fu durante un’assemblea di studenti che per la prima volta mi resi conto della violenza involontaria implicita in questa richiesta. Alcuni profughi avevano creato un gruppo musicale, «I tamburi di Mantova», che era spesso invitato a portare la musica africana in diversi contesti pubblici. Nel corso della performance musicale, a J.B. – che era fuggito in Libia per sottrarsi alle interminabili violenze nella regione del Nord Kivu congolese, dove buona parte della sua famiglia era stata massacrata – venne chiesto di raccontare la sua vita. Uomo colto e politicizzato, dopo alcuni minuti di narrazione scoppiò in lacrime e lasciò la sala. L’avevo sentito parlare in pubblico di politica, di pedagogia, di progetti lavorativi; l’avevo visto farsi promotore di iniziative che sottraessero i richiedenti asilo dell’ENA all’attesa passiva ed estenuante dell’esito della richiesta d’asilo; ma non fu in grado di reggere il racconto pubblico della sua vicenda personale: troppo complessi i sentimenti, troppo forte il pudore, troppo profondo e vivo il lutto. J.B., come quasi tutti coloro che vittime lo sono state davvero, non sopportava che questo marchio, e i ricordi collegati, si imprimesse indelebile su di lui. Rivendicava forse quello che Edouard Glissant chiama «diritto all’opacità» [11], ma la pressione del ‘nostro’ sguardo non glielo concedeva. «Uno sguardo – scrive Monica Massari – che rischiava di divenire terribilmente futile, se non addirittura umiliante, visto che poteva reiterare, involontariamente, la violenza che invece avrebbe voluto denunciare, come avviene talvolta nella tendenza all’iper-rappresentazione, alla sovra-esposizione del corpo migrante come corpo-vittima, come corpo-martire.»[12]
Il tema della narrazione di sé resta uno dei più complessi, intrecciato com’è a quello della lingua e della traduzione, alla violazione del diritto al pudore e all’oblio per ottenere qualche forma di regolarizzazione e di benevolenza sociale.
Qualche anno dopo, quando mi è stato chiesto di occuparmi come volontaria di accompagnamento alla richiesta d’asilo, ho colto ancor meglio la componente vessatoria di questo procedimento, basato sul racconto della propria storia da parte di persone spaesate, sopravvissute a traumi molteplici, portatrici di lingue, codici e modalità comunicative a noi sconosciute, provenienti da Paesi di cui la maggioranza degli europei, compresi coloro che devono valutare la loro richiesta, sa poco e niente. Solo la costruzione di un rapporto di fiducia, la presenza di un mediatore linguistico competente, l’ascolto empatico e il tempo necessario al dialogo nella sua accezione più profonda, consentono talvolta che la vera storia di ognuno affiori e che il richiedente asilo trovi la forza di parlarne. Ma il tempo delle istituzioni è a volte imprevedibile. Inoltre ci si trova spesso a seguire i percorsi legali di persone accolte, nei primi, cruciali mesi, da grandi centri i cui gestori sono poco propensi a perder tempo e denaro per l’accompagnamento legale, la ricerca di mediatori linguistici idonei e di buoni avvocati. Una situazione resa ancora più grave dal decreto n.46/2017, noto come decreto Minniti-Orlando, che elimina un grado di giudizio, e dal decreto 113/2018, il decreto Salvini, che, fra l’altro, elimina la protezione umanitaria, nega l’iscrizione anagrafica e riduce drasticamente -18 euro a persona come base d’asta negli ultimi bandi prefettizi- i fondi destinati all’accoglienza. Entrambi i decreti sono stati convertiti in legge.
L’unica strada legale per entrare in Italia, se si escludono i ricongiungimenti familiari, i motivi di studio e i sempre più ridotti accessi stagionali concessi per «decreto flussi», resta la richiesta d’asilo, che nella maggior parte dei casi viene rigettata sulla base della discutibile distinzione fra migranti economici e migranti forzati. Può risiedere regolarmente in Europa chi riesce a dimostrare in modo circostanziato, coerente e preciso di avere «fondato timore» per la propria vita in caso di rimpatrio.
Chi si è occupato di storia usando anche fonti orali, ha studiato gli inciampi e le fratture della memoria, ha cercato di cogliere i nessi tra verità storica, verità psicologica e verità narrativa; sa che l’accertamento della verità fattuale può dare rilievo e spessore alle narrazioni che affiorano a distanza di tempo, permette di valutare il rapporto fra eventi traumatici e rimozioni, i nessi fra le memorie individuali e i quadri sociali della memoria Ma la verità fattuale è frutto di un lavoro sistematico di incrocio e critica delle fonti e di ricostruzione dei contesti; tutto questo poco ha a che fare con il procedimento di richiesta d’asilo e con le pratiche seguite da membri della Commissioni Territoriali, giudici e, purtroppo, talvolta anche da avvocati per garantire l’effettività di questo diritto.
«Sovvertire l’insostenibile violenza dell’ignoranza» scrive Maurizio Veglio in un saggio prezioso per comprendere queste dinamiche[13]. Ma, per entrare in profondità nella storia di un richiedente, spesso non bastano i rapporti delle organizzazioni internazionali sui paesi di provenienza, talvolta nemmeno gli aggiornamenti quotidiani dei siti gestiti dai gruppi di opposizione di alcuni Paesi; occorrerebbe invece il confronto approfondito con studiosi -storici, antropologi, economisti- che in quei Paesi hanno esperienza di ricerca sul campo e -pratica tutta da consolidare- la consulenza di persone della diaspora. Solo così affiora la complessità degli Stati e delle comunità: dittature sanguinarie, conflitti armati, discriminazioni che mettono a rischio in modo conclamato la sopravvivenza; ma più spesso situazioni di povertà estrema determinate da questioni climatiche, sfruttamento selvaggio delle materie prime da parte di compagnie straniere, corruzione e totale inaffidabilità delle istituzioni locali che non garantiscono spesso nemmeno i diritti fondamentali. Emergono talvolta anche scenari familiari e comunitari che mettono a dura prova le nostre categorie interpretative -penso, ad esempio, al fenomeno sfaccettato chiamato «stregoneria»- e che per essere compresi hanno bisogno di una relazione di ricerca condivisa e dialogo.
In genere le prime narrazioni tacciono su questioni cruciali, quelle che, secondo i migranti, e con molte ragioni, sono per noi incomprensibili («se te l’avessi raccontato non mi avresti creduto») o delle quali non si parla per un sentimento di vergogna. Per tutti, per tutte c’è poi l’inferno del viaggio verso l’Europa: tratta, sfruttamento, abusi, torture, morti alle quali si assiste impotenti e delle quali molti si sentono in qualche modo corresponsabili.
Ma lo sguardo degli attori istituzionali che devono riconoscere chi va «diniegato» e chi no resta scettico e inquisitorio anche quando la realtà politica del paese di provenienza è nota, o almeno dovrebbe esserlo, a chi detiene la responsabilità di decidere.
La violenza, il pudore, l’oblio. La storia di L., ad esempio
L. arriva in Italia diciannovenne nel 2016, viene dal Gambia. Lui e la sua famiglia sono da sempre vicini all’UDP, la principale formazione politica che si oppone alla sanguinaria dittatura di Yahya Jammeh che dal 1994 all’inizio del 2017 tiene il potere nelle proprie mani violando sistematicamente i diritti umani, provocando la sparizione degli esponenti dell’opposizione, la corruzione, la tortura, l’uso politico della magia nera contro intere comunità.[14] Nel 2014, aggredito da un coetaneo appartenente sia all’etnia che al partito del dittatore (Prc), L. reagisce ferendolo leggermente. Viene arrestato dalla Nia, famigerato servizio di intelligence, e torturato. Uno zio garantisce personalmente per la scarcerazione del ragazzo e la famiglia consiglia a entrambi di fuggire. Il viaggio di L. attraverso Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger e infine Libia è dei peggiori: ricatti e sfruttamento da parte dei trafficanti, violenze delle bande di Asma boys[15] e infine le prigioni libiche, Sabratha in particolare, e nuove torture. Non tutto è dicibile, un oscuro senso di colpa alligna nell’anima di L.; le cose più difficili da elaborare riuscirà a raccontarle solo in gruppi di parola con altri richiedenti asilo, col sostegno di personale specializzato e buoni mediatori linguistici. Molto tempo dopo riuscirà a farlo anche con i volontari che hanno stabilito con lui le relazioni più profonde. Lui stesso imparerà a raccogliere i racconti più dolorosi di alcuni compagni aiutandoli a elaborarli. Nonostante il Gambia, il viaggio, le torture ripetute, L. era un ragazzo che al suo arrivo sapeva ancora sorridere e sperare, ma il non essere stato creduto dalla Commissione territoriale è stato il primo duro colpo al suo equilibrio.
Il 3 novembre 2016, mentre il Gambia è ancora in balia della dittatura agonizzante, e per questo ancora più feroce, di Jammeh, il presidente della Commissione territoriale che lo interroga, dopo aver letto il racconto che L. aveva fatto durante la presentazione della richiesta d’asilo, senza nemmeno riascoltare la sua narrazione dei fatti, gli pone questa sconcertante domanda:
D.: Se ho capito bene, lei, senza essere responsabile di azioni antigovernative, solo per aver procurato lesioni lievi a un coetaneo durante un litigio, anziché rivendicare la propria innocenza prese la drastica decisione di lasciare uno stato in pace come il Gambia per espatriare in uno stato pericolosissimo come la Libia. E’ così?
R.: Sì è così. In Gambia basta parlar male del Presidente per finire in prigione- risponde L.
Il fraintendimento, lo spaesamento sono evidenti; il Presidente incarica l’interprete di rileggere il verbale dell’audizione al ragazzo che alla fine lo sottoscrive. E qui entra in gioco il ruolo dell’interprete: «La massima delicatezza avvolge la relazione tra interprete e richiedente, chiamati ad armonizzare il respiro –sin dalle prime, decisive battute- nell’alternanza tra affermazione e traduzione.»[16]
Quante volte un richiedente asilo dell’Africa subsahariana viene tradotto in fase di richiesta d’asilo da un mediatore che non conosce nessuna delle lingue locali del Paese da cui proviene? Quante volte un richiedente non osa esprimere pareri o raccontare dettagli davanti a un interprete della sua stessa provenienza ma di etnia, posizione politica o religione diversa? Quanti riescono a parlare di omosessualità o di stupri in Commissione? Quante donne riescono a denunciare la tratta e le violenze subite? Capita che un mediatore linguistico si rifiuti di tradurre dettagli che ritiene poco credibili o che potrebbero gettare discredito sul paese d’origine o sugli ‘africani’ in generale. E’ accaduto a S., un altro ragazzo del Gambia. Ha assistito a una delle tante cacce alle streghe scatenate da Jammeh con l’aiuto di finti marabutti al solo scopo di terrorizzare in periodo elettorale la popolazione di alcuni villaggi.[17] Nel corso di questa operazione sua madre è stata catturata, drogata e imprigionata in uno dei peggiori carceri gambiani mentre suo padre moriva in ospedale. La donna uscì dopo un mese quasi impazzita e totalmente isolata dalla comunità. Il mediatore linguistico camerunense, colto e molto europeizzato, non volle tradurre questa storia in sede di richiesta d’asilo. Quando lo scoprì, il ragazzo si vergognò di quanto era accaduto alla sua famiglia e non ne parlò più per anni.
Di altre vicende so che i giovani narratori non vorrebbero che parlassi, alcuni me l’hanno detto in modo perentorio: «Fa parte del mio passato, adesso voglio solo dimenticare tutto»; oppure: «Anche se non metti il mio nome quella è la mia storia, gli altri non devono parlarne».
Non so se ci siano immaginari culturali a me sconosciuti che sottendono questa determinazione, ma risuona in me Il ragazzo che voleva dormire, di Aharon Appenfeld[18]. Erwin è un adolescente ebreo nato a Czernowitz, in Bucovina, sopravvive alla Shoah, che ha inghiottito entrambi i genitori, grazie alla fuga da un campo di concentramento. Alla fine della guerra si trova con molti altri profughi ebrei a Napoli. Dovrebbe prepararsi alla partenza per Israele sotto la guida di un istruttore dell’Haganah. Ma Erwin non riesce a emergere da un sonno profondo, un’«onda di tenebra» che lo protegge dalla realtà e lo imprigiona in un incessante dialogo onirico con i suoi genitori e le figure del suo passato; non ha fame; non vuole imparare la nuova lingua, l’ebraico, che lo separerà ancor più da quella delle origini; non ricorda, non vuole ricordare nulla. E, più ancora di lui, difende il suo diritto al silenzio e all’oblio Marc -coetaneo forte e silenzioso- che reagisce con violenza a ogni richiesta di dire da dove proviene, rifiuta perentoriamente di cambiare il suo nome con uno ebraico e decide di togliersi la vita. Andrà a popolare i sogni e le premonizioni di Erwin, fino a spiegargli brutalmente che «La morte è l’altra faccia della nostra vita».
Erwin e Marc mi parlano dei ragazzi africani che ho intorno, della loro forza ma anche della diffidenza, della reticenza e dello sfinimento intorpidito in cui alcuni piombano, dell’oblio che invocano e che il sistema d’asilo non consente, pretendendo racconti «circostanziati» a poco tempo di distanza da eventi traumatici di cui sono stati vittime ma qualche volta anche, forzatamente, protagonisti attivi. Silenzio, opacità, pudore. Un sentimento di cui parla Primo Levi ne La tregua descrivendo la reazione dei sopravvissuti al momento della liberazione di Auschwitz:
Non salutavano, non sorridevano; apparivano oppressi, oltre che da pietà, da un confuso ritegno, che sigillava le loro bocche e avvinceva i loro occhi allo scenario funereo. Era la stessa vergogna a noi ben nota, quella che ci sommergeva dopo le selezioni, ed ogni volta che ci toccava assistere o sottostare a un oltraggio: la vergogna che i tedeschi non conobbero, quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altri […]. Così per noi l’ora della libertà suonò grave e chiusa, e ci riempì gli animi, ad un tempo, di gioia e di un doloroso senso di pudore per cui avremmo voluto lavare le nostre coscienze e le nostre memorie della bruttura che vi giaceva.[19]
Il viaggio, la Libia, noi
Spesso, soprattutto negli ultimi anni, la bruttura più profonda è il viaggio, in particolare la permanenza in Libia. Esistono innumerevoli articoli, saggi, video, rapporti di agenzie internazionali per i diritti umani: tutti tentano di descrivere una situazione che il più delle volte gli autori stessi definiscono «indescrivibile».[20] Un territorio diviso tra milizie appartenenti a centri di potere diversi e bande armate che parrebbero indipendenti da ogni controllo, disseminato di trafficanti che facilitano i passaggi da un centro all’altro e vendono le persone al miglior offerente per sfruttarle o usarle come merce di scambio. Ovunque quelli che i ragazzi chiamano foyer, case o magazzini in cui il tenutario può trattenere i migranti in cambio di un duro lavoro ma anche tenerli prigionieri; ma ci sono anche le connection house, prigioni-bordello in cui vengono rinchiuse donne e ragazze in balia di organizzazioni legate a varie mafie. Poi i grandi centri di detenzione, più o meno ufficiali, quelli per cui i libici hanno i ‘nostri’ finanziamenti per contrastare l’immigrazione irregolare. Alcuni nomi ricorrono con frequenza: Sabratha, Az Zawiyah, Zwarab, Bani Walid, Zliten.
Qui i migranti subiscono torture e trattamenti disumani. Le persone vengono costrette a vivere in celle sovraffollate, in pessime condizioni igieniche, senza un’adeguata alimentazione e sottoposte a percosse quotidiane, a sevizie e, sempre, ai lavori forzati. Spesso tra i torturatori ci sono ragazzini, quasi bambini; come se occorresse addestrarli il più presto possibile alla tratta dei migranti, una sorta di apprendistato a un lavoro remunerativo.
Il calvario non inizia in Libia[21]. Dopo la quasi ovvia estorsione di denaro da parte di tutte le polizie di frontiera, ogni passaggio è segnato dalla presenza di passeur, spesso legati ai poteri locali, che chiedono soldi per accompagnare alla tappa successiva: qualche volta rispettano i patti, spesso abbandonano i migranti nel deserto, dove scaricano i corpi di chi non ce la fa. Tutti, per pagarsi le tappe del viaggio, lavorano per mesi. Anche qui il destino fa la sua parte: il datore di lavoro qualche volta paga, più spesso no; capita persino che si affezioni al giovane e gli insegni l’arabo o il francese, oppure paghi per farlo liberare dalla prigione in cui viene chiuso. Ma la violenza è l’elemento costante: dalle milizie Touareg del Mali che se non hai soldi ti spogliano e ti torturano, a quelle algerine[22]
M., ivoriano, nel 2016 mi racconta:
In Algeria siamo stati attaccati da banditi che erano d’accordo con l’autista. Chi non aveva soldi era costretto a quella che loro chiamavano «formazione militare»: ti costringevano a sdraiarti per terra nudi e loro camminavano sopra di noi e ci picchiavano. Poteva durare anche un’ora. Poi ci rimettevano sul camion . Da Timialuid a Tamanrasset succedeva la stessa cosa, evitavano la «formazione militare» solo quelli che potevano pagare. Ma io non avevo più soldi.
Le violenze diventano sistematiche in Libia. Il racconto che L. mi aveva fatto all’inizio sembrava uno dei più ‘normali’ tra quelli che avevo raccolto:
L’ultimo mese hanno cominciato a picchiarci, ho ancora la cicatrice. Il padrone che ci stava portando a Sabratha è venuto a chiedere di liberarci; abbiamo lavorato per lui quattro mesi, non ci ha pagato e ci ha portato da un suo amico che ci ha imbarcati per l’Italia.
Anni dopo mi racconta che uno dei torturatori libici di Sabratha, per estorcere denaro, comincia a sparare e uccide un suo compagno; L. chiede di lasciargli il tempo di leggere il Corano prima di fare la stessa cosa con lui. Il bandito lo guarda stupito: «Sei credente? Allora vai, questa volta Dio ti ha salvato.»
Il racconto più duro è quello di A., che porta i segni di torture psicologiche e fisiche, poi accertate dal medico legale, che non lo abbandoneranno forse mai:
A Sabah, quando siamo scesi, ero terrorizzato perché gli Asma Boys ci minacciavano con un fucile, come se giocassero con noi. Uno che era con me è stato fucilato mentre stavamo scappando. A Bani Walid ci hanno scaricati in una specie di stanza dei trafficanti, tantissima gente tutta insieme. Qui ci hanno costretto a spogliarci, siamo rimasti in mutande e ci torturavano. Erano libici, c’erano anche dei ragazzini piccoli. Ci spruzzavano dello spray negli occhi e in faccia. Una notte ci hanno messi in fila indiana, senza vestiti tutta la notte. Erano libici, c’erano anche dei bambini, i loro figli. Con noi c’erano tre ragazze nigeriane. Loro le hanno violentate. Poi hanno violentato anche gli altri, quelli più giovani. Anche me.
A. ha 18 anni, una famiglia abbastanza agiata; è partito dal Gambia per sfuggire all’incubo della dittatura di Yahya Jammeh. I trafficanti sanno che torturandolo e riprendendo col cellulare le torture possono estorcere soldi alla sua famiglia e in effetti il suo viaggio è più breve, ma anche più drammatico, di quello di altri.
Queste storie di violenze estreme raramente sono prese in considerazione dalle Commissioni territoriali e dai tribunali. Pare che ai tribunali poco importi anche di quello che invece tormenta la mia coscienza di cittadina: tutto questo vede le autorità europee direttamente coinvolte. Un coinvolgimento che ha raggiunto un apice nel «Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all’immigrazione illegale, al traffico di esseri umani», firmato il 2 febbraio 2017 a Roma dal Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Paolo Gentiloni e dal Capo del Governo di Riconciliazione nazionale dello Stato della Libia, Fayez Mustapa Serraj[23].
Nel 2016 erano giunti sulle coste italiane 181436 migranti, un picco mai raggiunto. L’accordo, finanziato con fondi italiani ed europei, ha come scopo principale fronteggiare la cosiddetta «emergenza sbarchi», ha durata triennale ed è tacitamente rinnovabile.
Capo della Guardia costiera di Zawiya, addestrata e munita di motovedette in seguito a questiaccordi, è Abd al Rahman al-Milad, noto con il soprannome di al-Bija, che il 7 giugno 2018 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite decide di sanzionare come uno dei principali trafficanti libici di uomini; è responsabile di atti efferati. Nel maggio del 2017 Al Bija è ricevuto in Italia come membro della delegazione libica su invito dell’Organizzazione Internazionale per le migrazioni (OIM).[24]
Il libro curato da Maurizio Veglio, L’attualità del male. La Libia dei Lager è verità processuale, analizza le implicazioni di un’importante sentenza della Corte d’Assise di Milano: il 10 ottobre 2017 condanna un cittadino somalo di ventiquattro anni alla pena dell’ergastolo. Il giovane, migrante forzato a sua volta, è riconosciuto responsabile di sequestro di persona a scopo d’estorsione aggravato dalla morte di alcuni sequestrati, violenza sessuale, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’imputato è membro di un’organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di migrantiche tra il 2015 e il 2016 avrebbe concorso a gestirealmeno due «campi di transito» situati in Libia, Bani Walid in particolare, in cui i migranti -in questo caso tutti cittadini somali- venivano imprigionati, torturati e minacciati in attesa del pagamento del prezzo necessario per raggiungere l’Europa. La sentenza è stata confermata in Appello il 20 marzo 2019. Il 22 giugno 2019 si esprime analogamente la Corte d’Assise di Agrigento nei confronti di un cittadino gambiano, al servizio di «soggetti arabi stanziali», condannato a dieci anni di carcere per le violenze commesse ai danni di migranti rinchiusi nel campo di Sabratha.
E’ indubbia la responsabilità di torturatori e trafficanti che operano al servizio di organizzazioni locali, ma all’origine di questa catena criminale stanno, oltre alle condizioni dei paesi di provenienza, anche le politiche d’accesso ai paesi europei[25], negli anni sempre più restrittive, e gli accordi con la Libia -ma anche con Niger e Sudan- che hanno messo i migranti nelle mani di chi, come ampiamente provato, abusa di loro fino a ucciderli.
Tutto ciò accade in spregio a tutte le convenzioni nate dopo la seconda guerra mondiale per garantire l’inviolabilità dei diritti umani. Su questi fondamentali trattati grava il problema dell’effettività, della capacità cioè di garantire e applicare diritti che purtroppo spesso restano solo sulla carta, soprattutto ai danni degli stranieri, che sempre più spesso diventano ospiti nemici.[26]
Nel marzo 2019 Fabio Levi ha tenuto a Mantova una lezione sull’antisemitismo. Il titolo che ci propose –Al termine della catena sta il lager (Primo Levi). Storia e consapevolezza del presente– tocca esattamente il cuore di ciò che ho cercato di dire.
Le parole di Se questo è un uomo ancora una volta ci inducono a riflettere su noi stessi e sull’ «infezione latente» che può diventare dispositivo politico e indurre a rappresentare l’altro non più come persona ma come insidia da eliminare:
A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che «ogni straniero è nemico». Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come una infezione latente; si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all’origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena, sta il Lager. Esso è il prodotto di una concezione del mondo portata alle sue conseguenze con rigorosa coerenza: finché la concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano. La storia dei campi di distruzione dovrebbe venire intesa da tutti come un sinistro segnale di pericolo.[27]
L’Italia ha conosciuto il dolore e la speranza della migrazione verso l’America e i paesi più ricchi dell’Europa; il pregiudizio e la discriminazione ai danni dei connazionali che dalle regioni del sud si sono spostati al nord, diventando spesso negli anni Sessanta avanguardie delle lotte sociali. Oggi gli uomini e le donne che arrivano nel nostro Paese possono esprimere -e spesso già lo fanno- una soggettività politica nuova e una ricchezza culturale imprevista[28]. Una nuova lingua e una nuova visione del mondo nasceranno solo attraverso la forza generativa del dialogo e della reciprocità. Forse sono l’unico antidoto a un «infezione» che non è più solo «latente».
Questo saggio di Maria Bacchi è uscito nel volume a più mani L’integrazione degli ebrei: una tenace illusione? Scritti per Fabio Levi, Silvio Zamorani editore, Torino, 2019.
[1] Marc Bloch, Apologia della storia. O mestiere di storico, Einaudi, Torino, 1969, p.41,
[2] L’incontro con Giuliana Tedeschi è raccontato in Maria Bacchi, Cercando Luisa. Storie di bambini in guerra. 1938-1945, Sansoni, Milano, 2000, pp. 250-256.
[3] Jerome Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, Feltrinelli, Milano, 1997, p.111.
[4] Il concetto di doppia assenza è al centro del libro del sociologo algerino Abdelmalek Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, Raffaello Cortina editore, Milano, 2002.
[5] Michel de Certeau, La scrittura della storia, «Il pensiero scientifico» Editore, Roma, 1977, pag. 56.
[6] Renate Siebert, Non dimenticare. Frammenti di una tradizione «negativa», in «Dedalus» n.10, 1993.
[7] A proposito di rimozioni pubbliche e individuali, cfr. anche il capitolo Memorie tra silenzio e oblio in Luisa Passerini, Memoria e utopia. Il primato dell’intersoggettività, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, pp. 25-45.
[8] Paul Ricoeur, La storia, la memoria, l’oblio, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2003, pp.127-128.
[9] Christa Woolf, Trama d’infanzia, e/o, Roma, 1994, p.52.
[10] Già nel 2004 e nel 2007 erano stati sottoscritti fra Italia e Libia intese e protocolli operativi per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione.
[11] Edouard Glissant, Poetica della relazione, Quodlibet, Macerata, 2005.
[12] Monica Massari, Il corpo degli altri. Migrazioni, memorie, identità, Orthotes Editrice, Napoli-Salerno, 2017, p.12.
[13] Maurizio Veglio, Uomini tradotti, Prove di dialogo con richiedenti asilo, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», fasc. n.2/2017, pag.27.
[14] https://www.acatfrance.fr/un-monde-tortionnaire/Gambie
[15] Gli Asma boys sono bande armate di criminali libici protetti dalle varie milizie.
[16] Maurizio Veglio, Uomini tradotti, cit., p.22.
[17] https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/gambia/9700397/Witchcraft-and-execution-the-darker-side-of-Gambia.html
[18] Aharon Appelfeld, Il ragazzo che voleva dormire, Ugo Guanda editore, Parma, 2009.
[19] Primo Levi, Se questo è un uomo. La Tregua, Einaudi, Torino, 1989, pag. 158.
[20] Maurizio Veglio (a cura di), L’attualità del male. La Libia dei Lager è verità processuale, ed SEB 27, 2018. Francesco Viviano, Adriana Ziniti, Non lasciamoli soli: storie e testimonianze dall’inferno della Libia. Quello che l’Italia e l’Europa non vogliono ammettere, Chiarelettere, Milano, 2018.
[21] cfr. “Limes” n. 6/2017, Mediterranei.
[22] Il passaggio per l’Algeria pare farsi sempre più difficile, come spiega il rapporto di Amnesty del 2017 https://www.amnesty.it/algeria-ricorso-alla-profilazione-razziale-espellere-oltre-2000-migranti/
[23] “La cooperazione tra le Parti deve concretizzarsi nella predisposizione di campi di accoglienza temporanei in Libia, sotto l’esclusivo controllo del Ministero dell’Interno libico. […] La Parte italiana si impegna a fornire supporto tecnico e tecnologico agli organismi libici incaricati della lotta contro l’immigrazione irregolare. Tali organismi sono rappresentati dalla Guardia di frontiera e dalla Guardia costiera del Ministero della Difesa e dagli organi e dipartimenti competenti presso il Ministero dell’Interno. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, le Parti si impegnano all’adeguamento e al finanziamento dei centri di accoglienza già attivi, attingendo ai finanziamenti disponibili da parte italiana e a finanziamenti dell’Unione Europea.»
[24] Cfr. Maurizio Veglio, Introduzione a L’attualità del male. Cit., pp. 11-12.
[25] Cfr, Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai giorni nostri, Carocci editore, Roma, 2019.
[26] Un’importante riflessione critica sulle politiche dell’ospitalità in Donatella Di Cesare, Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione, Bollati Boringhieri, Torino, 2017.
[27] Primo Levi, Prefazione a Se questo è un uomo, Einaudi, Torino, 1989, p.9.
[28] Vale la pena di leggere il dialogo fra Luigi Monti e Ahmed Diabaté, Le diaspore cominciano a organizzarsi, comparso sul numero 61 della rivista «Gli asini» e sul sito della rivista: http://gliasinirivista.org/2019/04/le-diaspore-iniziano-organizzarsi/