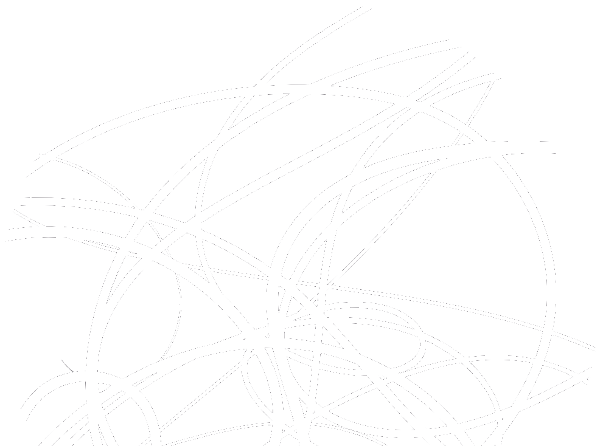In questo articolo, uscito nell’annuario di “Antropologia” (anno XIII n.15, 2013), Barbara Sorgoni riflette sui primi passaggi amministrativi con cui si attiva in Italia la procedura di asilo politico, analizzando l’interazione di tipo burocratico tra richiedenti asilo e soggetti istituzionali.
Dal 2011, con lo snodo fondamentale dell’Emergenza Nordafrica che ha determinato una svolta procedurale di grande impatto sulle politiche migratorie italiane, i cui effetti disgreganti vediamo in opera ancora oggi, sono state prodotte diverse ricerche etnografiche su questo nuovo “genere” che sono le storie prodotte dai richiedenti asilo per le commissioni territoriali. Storie da maneggiare con estrema cura per gli impatti che, al di là dell’esito della procedura per cui sono state prodotte, hanno sulle vite delle persone.
Relazioni burocratiche
Pubblico ufficiale: ((rivolta all’interprete)) chiedigli il nome di sua madre
Interprete: what is the name of your mother? Richiedente asilo: Ef
Interprete: the name of your mother . your mother’s name
Richiedente asilo: Ef
Interprete: EF? JUST EF?
Richiedente asilo: ((guarda l’interprete rimanendo in silenzio))
Interprete: ((rivolta al pubblico ufficiale)) dice Ef. Ef è effe in italiano. La lettera effe. Sarà l’iniziale del nome. Boh. Forse non vuole dircelo . non credo che non conosca il nome di sua madre
Nel “Modulo C/3” che il pubblico ufficiale sta contestualmente compilando al computer per formalizzare la prima richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato politico, compare infine la seguente dicitura: “maternità: F”.
Quello riportato è il frammento di un dialogo e della sua successiva trascrizione, una parte del processo di interazione che ho potuto osservare in una questura italiana tra un pubblico ufficiale, un’interprete designata dall’ufficio stesso ed un richiedente asilo, che identifica il primo passo formale nella procedura di richiesta di asilo sul territorio italiano da parte del giovane nigeriano che chiamerò Femi Okebiyi. Un frammento molto breve in effetti, estratto di un’interazione al contrario lunga e difficile che si è protratta per oltre due ore, che contiene già alcuni degli elementi su cui mi concentrerò in questo saggio come, per esempio, il ruolo di interprete culturale improvvisato dal traduttore e il processo di reiscrizione dello scambio verbale in un modulo amministrativo preformato compilabile al computer. Altri frammenti consentiranno di aggiungere alcune riflessioni su quanto è già stato osservato rispetto alla centralità della narrazione nella procedura d’asilo, e riguarderanno la disuguaglianza inscritta nell’interazione burocratica come specchio di una più ampia relazione sociale di tipo asimmetrico e gli effetti concreti dell’operazione di trascrizione e riduzione per finalità amministrative di storie complesse (raccontate di frequente nelle varie tappe del processo, in altre lingue e a diversi soggetti con mansioni varie) in moduli standardizzati a campi chiusi, utilizzati da chi dovrà infine decidere dell’esito della richiesta. O più in generale, come scrive Katrijn Maryns, sul fatto che negli incontri burocratici durante i quali si definisce l’ammissibilità della richiesta di asilo, “il detto spesso non viene trasformato nel dicibile” perché non rispecchia modi, visioni e codici istituzionalmente definiti (2006, 13).
Non propongo un saggio di antropologia linguistica, né una trattazione di questo ambito di studi[i]. Provo, invece, ad ispirarmi ad alcune interessanti suggestioni che provengono da una specifica letteratura – recente e ancora non molto nutrita, che nasce dall’intersezione di discipline quali antropologia, pragmatica e sociolinguistica – rivolta all’analisi dell’interazione in contesti istituzionali in cui vengono raccolte ed ascoltate le narrazioni dei richiedenti asilo. Tali indicazioni sembrano particolarmente utili per leggere alcuni passaggi della mia attuale ricerca etnografica su richiedenti asilo e rifugiati in diverse città dell’Emilia-Romagna, in particolare i momenti iniziali della procedura di richiesta di protezione internazionale.
Ci sono numerose differenze tra la condizione di richiedenti asilo e rifugiati nei campi profughi del Sud del mondo – ampiamente indagati dalla letteratura accademica o prodotta dalle istituzioni deputate alla gestione del fenomeno (sotto forma di statistiche e rapporti, dell’UNHCR[ii] o di varie Agenzie internazionali e Ong) – e le modalità di arrivo, le politiche e le procedure di riconoscimento, di controllo e di accoglienza nei paesi del Nord che sono, al contrario, un terreno di indagine più recente e meno indagato. I numeri prima di tutto, dato che su 43 milioni di persone costrette a migrare o fuggire secondo le stime ufficiali per il 2009 (UNHCR 2010), quattro quinti degli oltre 15 milioni di rifugiati si trovano nei paesi extra-occidentali. Un’altra differenza è senza dubbio l’attuale frammentarietà del fenomeno, sia nel senso che a migrare nel secondo caso sono essenzialmente singoli individui e solo raramente nuclei familiari (diversamente dal più classico spostamento di interi gruppi di profughi[iii]), sia nel senso che i meccanismi di gestione del fenomeno in Europa prevedono invii, spostamenti e ricollocamenti, accompagnamento alla frontiera, detenzione ed espulsione dei soggetti stessi, attraverso i territori di uno o più stati. Queste differenze hanno una ricaduta anche sulla metodologia di ricerca, necessariamente diversa dalle più numerose etnografie condotte all’interno dei campi profughi, che paiono consentire una ricerca di tipo più tradizionale tra persone culturalmente e linguisticamente omogenee e che risiedono nello stesso luogo per un periodo di tempo prolungato. Al contrario, “al Nord” oggi è virtualmente impossibile per un solo ricercatore riuscire a seguire uno stesso numero di soggetti e di storie attraverso tutto il percorso procedurale che va dalla prima richiesta all’eventuale riconoscimento di status, inclusi i probabili stadi di appello. Non è possibile prevedere in anticipo in alcun modo quanti e quali tra i richiedenti asilo che si possono incontrare e conoscere nelle prime fasi della procedura resteranno in uno stesso luogo o verranno “ricollocati” altrove durante lo svolgimento del processo, né chi riceverà il diniego e conseguentemente verrà rimpatriato o si renderà irreperibile, né infine chi, per questo o altri motivi, lascerà il territorio nazionale. Spesso non è neanche possibile dare per scontato che gli operatori o i pubblici ufficiali con i quali si entra in contatto all’inizio del percorso di ricerca resteranno assegnati alle stesse mansioni, visto l’alto turn-over che per vari motivi investe in Italia anche il personale dedicato alle procedure d’asilo. Così come non è detto, infine, che tutte le tappe istituzionali previste dalla procedura siano accessibili per il ricercatore; al contrario, in tutta Europa sono molti i passaggi istituzionali preclusi tanto ai ricercatori che agli operatori che forniscono assistenza[iv].
Soprattutto, il fatto che i diversi momenti del processo d’asilo siano seguiti da differenti soggetti con diverse mansioni, collocati in luoghi anche distanti tra loro, rende l’intero procedimento difficile da comprendere se non completamente oscuro, apparentemente ingiusto, faticoso e doloroso per gli stessi richiedenti asilo. L’opacità che accompagna tutto il percorso di asilo sarà un aspetto ricorrente nel corso di questo lavoro.
Gli elementi di frammentarietà inscritti nella procedura rimandano anche ad un’altra caratteristica dei processi di richiesta d’asilo in Europa, che pure condiziona fortemente tanto la metodologia di ricerca quanto l’esperienza dei richiedenti asilo: il fatto che, come ha scritto Nuruddin Farah (2003), rifugiati si diventa in un qualche punto di una traiettoria di vita durante la quale tale etichetta viene assegnata o negata ad alcuni soggetti all’interno di una complessa ed articolata relazione burocratica con altri soggetti. Vari autori hanno riflettuto sul processo di categorizzazione di chi è coinvolto in percorsi di migrazione forzata, sia in riferimento alla produzione di un nuovo oggetto di studio collegato alla costruzione di un tipo ideale di rifugiato, sia riguardo agli effetti di erosione dei diritti provocato dall’attuale proliferazione di etichette[v], passando per l’osservazione di Elisabeth Colson (2004) che sottolinea come una funzione di tale operazione tassonomica sia quella di ricordare ad alcune persone di essere sottoposte all’autorità di chi ha il potere di definirle.
L’elemento specifico che vorrei sottolineare è piuttosto il fatto che ad accomunare individui altrimenti diversi tra loro sotto ogni aspetto è l’esperienza condivisa e processuale dell’istituzionalizzazione dell’asilo. Non si tratta di negare che esistono importanti somiglianze e continuità nei fenomeni di sradicamento, violenza e fuga vissuti dai richiedenti asilo, né che l’imposizione di etichette copre al contempo realtà diversificate e altamente disomogenee tra loro[vi]. Si tratta piuttosto di riconoscere come sia impossibile cogliere aspetti salienti del fenomeno dell’asilo al di fuori delle relazioni burocratiche che, dal primo arrivo all’eventuale riconoscimento di un qualche tipo di protezione internazionale, coinvolgono i richiedenti in interazioni amministrative continue (ancorché complesse, frammentate e spesso poco chiare) con differenti figure istituzionali in grado di determinare l’esito di quelle richieste, e quindi in parte delle loro vite future. Rispetto alla fissità e alla presunta neutralità di categorie ascritte, e alla pretesa di controllo messo in campo attraverso le procedure burocratiche, le storie e le voci dei richiedenti asilo indicano la loro intenzione e capacità di ricomprendere la propria condizione presente all’interno di traiettorie di vita più ampie dei processi istituzionali nei quali sono intrappolati[vii] , la difficoltà di annullare la concretezza di tali procedure amministrative e, infine, le possibili strategie individuali messe in atto – a partire dalle stesse tecniche narrative – per tentare di proporsi come soggetti agenti all’interno di campi di relazioni comunque fortemente diseguali.
Si tratta, quindi, di collocare l’analisi dentro i contesti istituzionali in cui avvengono a varie tappe interazioni significative che, nel mettere in atto in specifici luoghi una procedura d’asilo spesso concepita in contesti anche molto distanti, di fatto la forgiano e comunque la interpretano e traducono. Dal primo istante in cui si decide di avanzare richiesta di protezione internazionale, i richiedenti asilo in qualsiasi paese d’Europa si trovano immessi in un percorso segnato dai ritmi delle varie istituzioni preposte a gestire il fenomeno; ritmi scanditi da periodici e ripetuti incontri con differenti attori istituzionali in diversi contesti, i quali hanno (o appaiono avere) il potere di definire in modo sostanziale le condizioni di vita presenti e soprattutto il futuro dei richiedenti stessi. In ciascuno di questi incontri, l’interazione burocratica prende la forma di colloqui-interrogatori[viii] durante i quali viene ripetutamente chiesto ai richiedenti asilo di (ri)produrre una narrazione della propria storia di vita i cui elementi centrali – ricapitolati ogni volta tutti o selettivamente, in forma orale oppure scritta – comprendono solitamente: la dichiarazione della propria identità individuale e familiare, la vicenda di fuga e le sue ragioni, il percorso di fuga e le sue modalità, l’eventuale produzione di prove a sostegno di quanto affermato. All’interno dell’interazione burocratica che definisce la procedura d’asilo, il piano narrativo appare quindi centrale e si configura come l’altro terreno di analisi che non può essere facilmente messo da parte.
Narrazioni
In approcci linguistici che presuppongono l’universalità della funzione narrativa, il racconto della storia personale – intesa in senso ampio come la capacità di trasmettere una sequenza di eventi di vita effettivi o possibili, mediante l’uso di differenti generi e modi – è considerato un mezzo essenziale per poter conferire senso all’esperienza: l’attività narrativa consente a chi parla di assegnare un ordine coerente ad eventi altrimenti sconnessi tra loro, e di creare un senso di continuità tra passato, presente e futuro; consente, infine, di mettere in relazione il sé di chi narra con il più ampio contesto sociale. A questa definizione classica della relazione tra narrazione e soggettività, Elinor Ochs e Lisa Capps (1996) affiancano un’osservazione particolarmente pertinente per il contesto in esame: il fatto che l’attività narrativa pone chi racconta e chi ascolta o legge nella posizione “paradossale” di estrarre coerenza dall’esperienza vissuta, e che tale sforzo di riconciliare aspettative e vissuto è particolarmente stridente nelle storie che riguardano casi di sofferenze mentali e fisiche, e/o contesti di repressione politica.
Questa prospettiva si è rivelata decisamente fertile, per esempio in quei settori dell’antropologia medica e dell’etnopsichiatria impegnati appunto in casi di sofferenze mentali e fisiche dovute a sradicamenti e migrazioni forzate connessi a fenomeni di repressione politica, dove l’accento è posto sulla necessaria frammentazione delle narrazioni personali di sofferenza, violenza vista o subita e fuga, nonché sulla necessità di riconnettere gli esili fili di senso all’interno di discorsi di disagio o malattia espressi secondo canoni e modalità narrative culturalmente dirette. Disagi e sofferenze che non possono quindi essere efficacemente affrontati nella cura da saperi e pratiche mediche che non sappiano ripensarsi criticamente e riflessivamente, a partire dal riconoscimento delle proprie matrici culturali[ix].
Nel saggio oramai classico di antropologia linguistica sopra citato, compariva anche un riferimento alle “asimmetrie narrative” che rimandano al valore assegnato tanto a differenti versioni della storia quanto a diversi modi e convenzioni del narrare, suggerendo di considerare in particolare nei vari contesti chi è autorizzato a narrare una storia, e chi ha il potere di decidere quando e in quale contesto una storia possa (o debba) essere raccontata, e a chi. Proprio l’attenzione al contesto sociale più ampio all’interno del quale sequenze significative di eventi discorsivi prendono corpo, e soprattutto il passaggio dall’analisi del contesto a quella dei processi di contestualizzazione, ha reso da tempo centrale per molte discipline lo studio delle narrazioni (performance, storie di vita e interazioni comunicative) come pratiche sociali: in particolare l’antropologia, la linguistica, l’analisi del discorso ma anche la psicologia, la sociologia e la storia. Sempre più di frequente a partire dalla metà degli anni ’80, gli studi sulla produzione dei testi partono dal riconoscimento che una reificazione del contesto in quanto descrizione oggettiva di ciò che circonda l’evento comunicativo, comporta il rischio di nascondere i modi attraverso i quali la stessa comunicazione può intervenire sul contesto. In questo senso, analizzare i processi di contestualizzazione significa prendere in considerazione anche l’agency intesa come capacità dei partecipanti all’interazione comunicativa di esaminare questa in modo riflessivo e contribuire attivamente ai processi di negoziazione di senso all’interno delle relazioni sociali[x]. Soffermandosi sul contestualismo nel suo saggio sull’antropologia dei processi educativi, Alessandro Simonicca nota che negli ultimi decenni le “sinergie e le co-implicanze fra studio della lingua e della cultura si mostrano sempre più frequentemente” (2011, 53) e cita a tale proposito il caso dell’antropologa Shriley Heath che nei suoi più recenti lavori sposta l’enfasi dallo studio del linguaggio a quello della “qualità della vita”. In modo analogo e significativamente nello stesso periodo, l’antropologo e linguista Jan Blommaert (2009) invita la sociolinguistica a ritornare a radicarsi “nell’etnografia come epistemologia e metodologia”, per potere cogliere la sfida attuale posta dalla globalizzazione e dalla mobilità in tutte le sue forme, come aspetti salienti delle esperienze dei richiedenti asilo.
Se è perciò vero che gli ultimi anni hanno visto una proliferazione di lavori che affermano la centralità delle connessioni tra narrazioni e processi sociali, la linguistica e l’antropologia hanno iniziato solo di recente ad occuparsi dei modi in cui differenti contesti partecipano alla costruzione dei testi discorsivi – e in cui la funzione delle narrazioni muta al variare delle condizioni sociali – in situazioni caratterizzate da alti livelli di conflitto[xi], o da incertezza e disuguaglianze, quali sono in particolare le esperienze di migrazione forzata. Lo spostamento di attenzione verso situazioni di tale tipo ha in un certo senso portato a osservare sotto una nuova luce proprio i processi di contestualizzazione, costringendo gli autori a riconsiderare fino a che punto alcuni soggetti implicati in interazioni discorsive in contesti istituzionali caratterizzati da forte asimmetria possano di fatto negoziare attivamente i significati e i termini del discorso stesso[xii].
Gli eventi comunicativi che hanno luogo all’interno di contesti istituzionali si compongono di affermazioni esplicite e apertamente espresse ma anche di significati impliciti e non ufficiali, che rimandano ai ruoli sociali dei partecipanti – a loro volta definiti da più ampie relazioni sociali – all’interno di campi di forza dove i soggetti si definiscono a vicenda anche se non necessariamente a partire da posizioni paritarie: per dirla con Bourdieu, è “l’accesso agli strumenti legittimi di espressione, dunque la partecipazione all’autorità dell’istituzione, che crea tutta la differenza” (1988, 85). In questi contesti il differenziale simbolico risulta tra l’altro dal fatto che, solitamente, le interazioni tra attori istituzionali e loro “clienti” sono organizzate e gestite dai primi, e che i due tipi di partecipanti non condividono le stesse conoscenze o gli stessi tipi di linguaggio (Briggs 1997b), né appunto l’accesso alle stesse risorse materiali e simboliche. Tale asimmetria risulta ancora più marcata nei casi in cui i soggetti istituzionali coinvolti nell’interazione sono pubblici ufficiali, esperti o operatori implicati nelle procedure di richiesta d’asilo: è questo infatti uno dei luoghi dove con maggiore forza viene esercitato il potere dello Stato (Collins 2005). È anche, possiamo aggiungere, uno dei luoghi dove tale potere si esplica attraverso uno scrupoloso controllo delle narrazioni richieste, e dove le storie di vita – raccontate ripetutamente solo in alcuni momenti stabiliti dai tempi amministrativi, ad alcuni soggetti di volta in volta selezionati e di fronte ad un uditorio ristretto (nessuna di queste condizioni potendo essere decisa o contrattata dal richiedente asilo/narratore) – assumono una centralità assoluta, poiché è la loro credibilità e veridicità che determina l’esito di procedure dalle quali dipende la vita futura dei richiedenti, e in alcuni casi la vita in sé. Tanto centrali che ci si potrebbe ragionevolmente chiedere come mai sistemi legali moderni ed avanzati che possono utilizzare metodi di verifica più sofisticati, finiscano per dipendere interamente dall’analisi di credibilità e coerenza delle narrazioni (Blommaert 2001).
Una volta riconosciuto il ruolo strategico delle storie di vita per la determinazione dello status di rifugiato, e che coerenza e verosimiglianza vengono fatte emergere attraverso un minuzioso scrutinio dei dettagli forniti, risulta maggiormente chiara la presenza di “asimmetrie nascoste” inscritte in questo tipo di relazione istituzionale. Solo alcuni eventi sono considerati dettagli salienti dai soggetti che dirigono la procedura, e tali dettagli non necessariamente coincidono con quelli forniti dai richiedenti o da questi considerati cruciali nell’economia della procedura (e viceversa). Poiché solo alcuni soggetti hanno la possibilità di definire infine che cosa conti come realtà, la procedura di richiesta d’asilo porta ad interrogarsi su cosa significhi trovarsi al cospetto di un sistema burocratico nel quale solo alcuni specifici “materiali” sono richiesti ed attesi[xiii]. La questione già accennata in precedenza, dello scarto sempre presente negli eventi discorsivi tra esperienza del narratore ed aspettative dell’uditorio, diviene qui non solo estrema ma anche qualitativamente peculiare. Facendo riferimento agli studi di etnografia della comunicazione, in questo saggio vorrei mostrare come le ripetute azioni di raccolta, traduzione e trascrizione delle storie dei richiedenti asilo da parte di funzionari e operatori durante lo svolgersi della procedura fungono da filtro rispetto alle storie stesse, fino a depotenziarle e svuotarle di significato e a funzionare a detrimento della loro stessa coerenza e credibilità[xiv]. L’analisi dell’uso delle narrative in questo tipo di interazione burocratica consente, inoltre, di ripensare il più classico tema della relazione tra fatti e trame, verità e rappresentazione: nella procedura d’asilo chi narra è spesso costretto a selezionare o fornire eventi (immaginati come) maggiormente accettabili, cioè adatti, attesi o richiesti in quel determinato contesto, necessariamente sollevando problemi morali di responsabilità e verità storica[xv].
Un esempio di esercizio di controllo estremo sulle narrazioni di sofferenza e fuga di richiedenti asilo è fornito da Marco Jacquemet (2005) per il caso del conflitto in Kosovo quando nel 2000, circa un anno dopo la sua fine, apparve chiaro ai funzionari dell’UNHCR di stanza a Tirana che molte delle richieste di asilo provenivano in realtà da albanesi che “si spacciavano” per kosovari. Il personale delle Nazioni Unite decise di smascherare “gli impostori” modificando in modo radicale la procedura relativa alla prima richiesta, impedendo di fatto ai richiedenti di raccontare liberamente la propria storia e sottoponendoli al contrario a test e domande di controllo su lingua, cultura e toponimi “genuinamente” kosovari. Analizzando il modo in cui venne rapidamente imposto questo mutamento nella prassi amministrativa, Jacquemet mostra come un controllo estremo ed unilaterale sulle narrazioni possa portare all’eliminazione delle stesse. Mostra, inoltre, la debolezza di un metodo che si affida all’analisi delle storie, la conseguente paura dell’istituzione di perdere il controllo sull’esito della procedura e quindi il riconoscimento implicito di un certo potere dei richiedenti asilo di manipolare le narrazioni in modo strategico. Mostra, infine, come in tale frangente sia di fatto sottile il confine tra colloquio e interrogatorio poliziesco, o persino processo giudiziario. In modo in parte analogo, proprio la crescente ossessione in Europa per i “falsi” rifugiati (quelli considerati imbroglioni o impostori) è posta in relazione con uno svuotamento progressivo della centralità della narrazione come “pilastro della prova”, e con una parallela crescita di importanza di altri tipi di evidenze: il corpo ad esempio, attraverso un aumento esponenziale di richieste di certificazioni mediche considerate, per vari motivi, maggiormente attendibili (Fassin e D’Hallouin 2007).
Traduzioni, trascrizioni
Uno degli aspetti di maggiore complessità delle procedure d’asilo (come processi amministrativi che impiegano tempi burocratici anche molto lunghi e si svolgono attraverso catene di interazioni, in ciascuna delle quali le singole pratiche possono rimanere incagliate in modo imprevedibile[xvi]), risiede nel fatto che le prassi amministrative e i significati che le informano e che queste veicolano, necessariamente osservabili a partire dai contesti locali in cui prendono corpo, sono collegati ad ideologie, pratiche discorsive sociali e istituzionali, e processi materiali di più ampia portata, prodotti altrove e circolanti a livello transnazionale[xvii]. La sfida analitica che tali contesti pongono riguarda la possibilità di mantenere lo sguardo “etnograficamente focalizzato” sull’osservazione specifica dei contesti locali tentando al contempo di riconnettere la microanalisi a livello locale con i processi sociali di portata globale (De Fina e Banyham 2005, 6).
Ritengo che una possibilità di cogliere questa sfida consista nel riconoscere il ruolo primario che i singoli soggetti istituzionali di volta in volta esercitano nell’attivare e mettere in pratica nei rispettivi contesti lavorativi indicazioni, norme e procedure che ricevono da altri centri (nazionali, extranazionali) e che essi provvedono a filtrare attraverso informazioni, immaginari e conoscenze accumulate con l’esperienza ma anche attinte a loro volta da diverse fonti di informazione e immaginazione, anch’esse circolanti su più ampia scala. Nel caso delle procedure di richiesta d’asilo in Italia (e con molte analogie nel resto d’Europa), i soggetti istituzionali implicati comprendono diverse categorie di attori sociali: personale di prefetture e questure, esperti legali ed avvocati, traduttori linguistici, operatori e/o assistenti sociali, personale medico (inclusi psicologi e psichiatri), volontari. Virtualmente tutte queste categorie di soggetti possono intervenire nei vari contesti deputati alla gestione del fenomeno dell’asilo in Italia – CARA o progetti di accoglienza gestiti dallo SPRAR[xviii] – e in diversi momenti di ciascuna traiettoria di protezione. Sono, quindi, coloro che traducono le ideologie e le norme transnazionali di protezione umanitaria al livello locale attraverso l’applicazione delle procedure d’asilo.
Affrontando il tema dei diritti umani universali applicati ai casi di violenza domestica sulle donne in alcuni contesti specifici, l’antropologa Sally Merry (2006) propone di procedere ad una “mappatura di chi sta in mezzo”, intendendo con middle proprio quell’universo variegato composto da figure istituzionali, attivisti politici e membri di associazioni di volontariato, che attraverso differenti strategie tentano di applicare, e quindi interpretare e tradurre a livello locale, ideologie giuridiche transnazionali pensate come universali. Il suo saggio compara due differenti approcci adottati in alcuni progetti in difesa dei diritti delle donne, quello della replica e quello dell’ibridismo, e mostra come le differenti strutture sociali e categorie culturali – come la composizione della famiglia, i ruoli di genere, il concetto di onore maschile, e la stessa idea di violenza – interferiscano in modo sensibile con i programmi e le strategie adottate dagli operatori locali, producendo esiti difformi. Mentre nell’approccio della replica (analizzato attraverso un progetto fondato ad Hong Kong negli anni ottanta) il modello transnazionale è molto forte e determina struttura dell’organizzazione, missione ed ideologia di intervento, nell’approccio ibrido (esemplificato dai nari adalats, i tribunali femminili sorti in India a metà degli anni novanta) forma dell’organizzazione, finalità e tipi di intervento sono definiti in modo prioritario da istituzioni e valori locali, così riducendo in parte l’effetto di imposizione di una visione occidentale e modernista su individui e società. Ma dato che attivisti e operatori dei progetti – questi “traduttori di diritti umani” – mediano tra mondi e lingue di diseguale potere e dipendono essi stessi dai fondi dei paesi donatori del Nord, in entrambi gli approcci essi riconfezionano le storie delle vittime di violenza nel linguaggio appropriato dei diritti umani universali, reinterpretando esperienze e categorie ricevute in lingue marginali nell’atto di tradurle nelle lingue “forti” del Primo Mondo (Asad 1997). In maniere differenti, entrambi i mondi tra cui essi mediano limitano e condizionano i modi, gli stili e le possibilità del loro lavoro di traduzione.
Nelle richieste di protezione internazionale, la relazione burocratica – di cui in apertura ho segnalato la centralità sia per il funzionamento della procedura, che per poter cogliere analiticamente il significato dei processi di protezione internazionale – è quindi cruciale anche in quanto luogo di incontro e connessione tra piano locale e indicazioni globali. Il middle nel caso specifico che intendo trattare qui sono in primo luogo i funzionari di polizia e i pubblici ufficiali che raccolgono la prima richiesta di riconoscimento di status di rifugiato, e gli operatori che seguono la richiesta[xix].
Anche i richiedenti asilo possono giocare questo ruolo di traduttori a metà strada tra globale e locale, almeno nella misura in cui riescono a portare nelle loro storie pezzi di mondo: si tratta, nelle parole di Jan Blommaert (2001, 444), delle parti delle loro narrazioni nelle quali conflitti e fenomeni transnazionali come guerre, sconvolgimenti politici e carestie vengono inscritti nello spazio dell’esperienza personale, collegando a questi i motivi di paura e insicurezza, ed offrendo tali argomenti come basi per ottenere l’asilo. Come già nel caso degli attivisti dei diritti umani, la cornice istituzionale più ampia nella quale le loro possibilità narrative sono inserite condiziona e in parte determina la forma finale della narrazione stessa. Blommaert nota, infatti, che proprio tali dettagli possono essere al contrario recepiti dalle istituzioni che dirigono la procedura come inutili aggiunte, una sorta di rumore di fondo che va eliminato dalla storia del richiedente; una considerazione che risuona molto vicina a quella avanzata da Liisa Malkki diversi anni fa, quando nella sua etnografia sui campi per profughi Hutu in Tanzania scriveva che gli amministratori erano soliti sfoltire le storie, per arrivare “alla nuda realtà dei fatti” (1996, 384).
Attraverso tutte le tappe previste, un ruolo di primo piano spetta infine agli interpreti, coloro che traducono dalla lingua nativa del richiedente asilo (o da questi scelta) alla lingua dello Stato nel quale è richiesta la protezione (e vice versa), e nel contempo interpretano tanto i significati delle narrazioni che quelli delle procedure, intervenendo in modo sistematico e consistente su entrambe e quindi, infine, sullo svolgimento dell’intero iter di protezione internazionale.
La richiesta di Femi Okebiyi
In Italia, la prima richiesta formale di asilo va presentata in questura o commissariato. Qui i richiedenti devono sostenere un colloquio che consente al pubblico ufficiale di riempire un verbale preformato (Mod. C/3) contenente alcune domande generali in campi chiusi: le proprie generalità, informazioni sull’identità dei familiari e stato di famiglia, cittadinanza, appartenenza etnica e religiosa, documenti posseduti, lingue parlate, eventuale titolo di studio e/o professione, itinerario del viaggio (paesi attraversati durante la fuga e mezzi utilizzati, durata di ogni tappa, luogo e modalità di ingresso in Italia), eventuali condanne ed eventuali richieste d’asilo avanzate precedentemente. Una casella apposita dedicata ai motivi della fuga e della richiesta di protezione, specifica che questo punto deve essere allegato a parte sotto forma di memoria scritta da prepararsi a cura del richiedente stesso in una qualsiasi lingua preferita. Durante il colloquio sono solitamente reperibili interpreti professionisti per inglese e francese, mentre per altre lingue la disponibilità varia a seconda dei luoghi e può capitare che si faccia ricorso a contatti informali stabiliti in precedenza con stranieri o associazioni di migranti esistenti sul territorio. Anche per questo aspetto condizioni e procedure mutano sensibilmente tra città e questure diverse. In uno dei luoghi in cui ho condotto la ricerca, un funzionario della Questura spiegava che in tale occasione “non c’è un reale bisogno di ricorrere ad un interprete ufficiale, poiché la vera partita si gioca di fronte alla Commissione Territoriale”. Nella realtà, come uno degli avvocati esperti nella procedura ha chiarito, le informazioni fornite nei passaggi successivi vengono sempre confrontate con le dichiarazioni rilasciate nel primo colloquio, e divergenze o incoerenze rispetto a quest’ultimo possono costituire motivo di rigetto della domanda. Ciò è riscontrato anche in altri paesi come ad esempio Belgio, Regno Unito e Stati Uniti d’America (Maryns 2006; Bohmer e Shuman 2008).
Lo scambio verbale riportato in apertura di questo lavoro si è svolto nel Commissariato di uno dei luoghi in cui ho condotto la mia ricerca basata sull’osservazione partecipante di alcune tappe della procedura di asilo[xx]. Oltre ai tre soggetti impegnati attivamente nell’interazione – il pubblico ufficiale, l’interprete italiana per la lingua inglese, e il giovane richiedente asilo – all’incontro era presente anche l’operatore del progetto SPRAR locale, al quale era stato richiesto di accompagnare il richiedente. L’operatore ed io (che avevo ricevuto il permesso di assistere da tutti i soggetti coinvolti, dopo avere chiarito le finalità della ricerca) potevamo ascoltare senza intervenire o interferire in alcun modo. Nella stessa stanza, infine, erano presenti altri due pubblici ufficiali intenti a svolgere differenti mansioni alle loro rispettive scrivanie.
La storia di Femi Okebiyi è lunga e complessa: al nostro primo incontro la sua fuga, iniziata in Nigeria da oltre quattro anni, lo aveva portato ad attraversare o ad essere inviato e trattenuto in diversi paesi dell’Africa e dell’Europa. Ma di quanto racconta su questo lungo viaggio soltanto le traiettorie da un luogo geografico all’altro e le relative date vengono trascritte nel modulo, o poco più. La prima cosa che colpisce osservando l’interazione durante il colloquio è l’insistenza con cui chi è costretto a narrare un percorso di vita faticoso e molto complesso, è simultaneamente pressato con sollecitazioni mirate a ridurre i “particolari” e attenersi a risposte dirette e stringate, a nudi fatti trascrivibili all’interno delle caselle precostituite del Modulo. Né il pubblico ufficiale né l’interprete usano mai un atteggiamento aggressivo, minaccioso o intimidatorio, e le due donne appaiono semmai cortesi e distaccate. Ma nei vari passaggi in cui la risposta ricevuta non è quella attesa – quando appare incompleta, o al contrario caotica per troppa ricchezza di dettagli – l’una o l’altra intervengono riempiendo silenzi e incertezze con proprie deduzioni. Lo scambio che ho riportato in apertura sul nome della madre ne è un esempio. La risposta ricevuta non è ritenuta soddisfacente perché il suono pronunciato dal richiedente asilo viene identificato dall’interprete – italiana e diplomata presso una scuola per traduttori – con una lettera dell’alfabeto inglese (F) e quindi tradotto come una iniziale; questo la porta a ripetere la domanda in modo insistente alzando il volume della voce. Non sortendo alcun effetto, sostituisce il silenzio del narratore con una propria interpretazione (boh . forse non vuole dircelo . non credo che non conosca il nome di sua madre!), che tradisce frustrazione e contemporaneamente insinua, con una doppia negazione, un dubbio sulle capacità cognitive – o forse affettive – del richiedente asilo[xxi].
Il breve scambio fa emergere anche l’enorme potere di cui gode l’interprete in quella specifica circostanza: il funzionario di polizia spiega fin dall’inizio di non conoscere affatto l’inglese e ciò la rende interamente dipendente dal filtro dell’interprete. È quest’ultima infatti a spiegarle in modo perentorio che il richiedente asilo sta fornendo solo l’iniziale del nome (Ef è effe in italiano . la lettera effe), escludendo categoricamente qualsiasi possibilità alternativa[xxii]. E tale perentorietà mostra, infine, come il lavoro di traduzione sia qui un’operazione che vuol far combaciare singole parole tra lingue differenti, senza avvertire la necessità di fare riferimento alla forma di vita in cui la lingua è utilizzata[xxiii]: è la posizione privilegiata di chi può permettersi di non dovere intrattenere un vero dialogo con il proprio interlocutore (Asad 1997, 218).
Un intreccio simile – fatto di ignoranza del contesto sociale e culturale di provenienza del richiedente asilo che si sta ascoltando, di incomprensioni sostituite da ipotesi, e di autorevolezza derivante dalla “posizione sociale” del traduttore (un interprete di professione) – riappare poco dopo nel corso del colloquio, questa volta rispetto ad una delle domande più significative per la determinazione dello status di rifugiato, quella relativa all’appartenenza etnica.
Pubblico ufficiale: ((rivolta all’interprete)) chiedigli se appartiene a qualche gruppo etnico
Interprete: do you belong to a specific ethnic group?
Richiedente asilo: ((guarda l’interprete confuso))
Interprete: there are many groups many families apart from the State
Richiedente asilo: no
Interprete: in Africa . there are many special groups
Richiedente asilo: language? My language?
Interprete: no not the language . you know in Africa . there are Hutu . Tutsi…
Richiedente asilo: ((scuotendo forte la testa)) no no
Interprete: so you don’t belong to a special group
Richiedente asilo: NO
Interprete: ((rivolta al pubblico ufficiale)) dice di no . scrivi nessun gruppo etnico
Anche in questo caso l’incomprensione deriva dal fatto che l’interprete non sa offrire un utile sostituto per “gruppo etnico”, e nel tentare di spiegare ricorrendo via via a termini che ritiene sinonimi, mostra di non sapere di cosa si stia parlando, aggiungendo così ulteriori elementi di confusione. Il richiedente asilo sembra ad un certo punto intuire quale possa essere il senso della domanda, e prova ad offrire una via d’uscita inserendo la lingua, che nel suo caso indica anche l’appartenenza etnica. Ma l’interprete non coglie la possibilità; al contrario, respinge prontamente indietro il tentativo di Femi di partecipare al dialogo in modo più attivo, assumendo una posizione ex catedra dall’alto della quale spiega, ad un richiedente asilo africano, che in Africa ci sono Hutu e Tutsi. Possiamo immaginare che la reazione fortemente assertiva del richiedente asilo scaturisca a quel punto dal timore di trovarsi attribuita una differente identità, una falsa dichiarazione che sarebbe assolutamente deleteria per l’esito della sua richiesta. È con evidente frustrazione che l’interprete comunica infine alla funzionaria di polizia che il richiedente afferma di non appartenere ad alcun gruppo. Sul Modulo C/3 risulta scritto “Gruppo etnico: NESSUNO”.
A questa lettura dell’interazione si potrebbero aggiungere alcune considerazioni extra-linguistiche. Per esempio, il Manuale per intervistare i richiedenti asilo pubblicato dall’UNHCR (s.d.) prescrive che chi intervista si rivolga sempre e comunque direttamente al richiedente, anche se in presenza di interprete. Nella procedura osservata, questo viene sistematicamente ignorato ed il continuo riferirsi invece all’interprete da parte del pubblico ufficiale (“chiedigli se”) tradisce un’intimità tra le due donne che in alcuni casi finiva per escludere del tutto il richiedente dall’interazione: le considerazioni metapragmatiche dell’interprete (“non si capisce”, “mi sembra vago su questo punto”, “non si sa spiegare bene in inglese”) sono rivolte sempre unicamente al pubblico ufficiale solo in italiano e mai tradotte. In modo analogo, e contrariamente a quanto espressamente richiesto dal Manuale dell’UNHCR, il pubblico ufficiale alla fine rilegge quanto ha trascritto in italiano e ne chiede conferma; la risposta affermativa arriva direttamente dall’interprete senza che venga fornita alcuna traduzione del verbale al richiedente asilo. Questi è poi invitato a firmare sotto la seguente dicitura (in italiano): “io sottoscritto dichiaro che il contenuto del presente verbale mi è stato letto in una lingua da me conosciuta…”.
Come ricorda Blommaert (2001), la procedura d’asilo si compone di una manciata di incontri nei quali il richiedente produce una storia, e di una frenetica produzione di testi su quella storia: una massa di comunicazioni scritte in un linguaggio legalistico che parlano per il richiedente asilo. Il Modulo burocratico non è pensato per accogliere la complessità delle storie e consente essenzialmente di inserire liste di nomi o eventi e relative cronologie. In un saggio sulla trascrizione dello Swahili nel Congo belga coloniale, Johannes Fabian (1991) esamina i primi vocabolari prodotti sul posto chiedendosi se questo genere di descrizione linguistica non riveli un “interesse cognitivo” ad assumere il controllo della comunicazione, attraverso l’imposizione unilaterale di regole proposte come standard oggettivi e scientifici, quindi universali. Identifica così tre operazioni di base utilizzate per ridurre il parlato allo scritto – nominare, elencare e classificare – come forme di astrazione della lingua dall’uso e dal contesto che non necessariamente migliorano la comunicazione interculturale, ma sicuramente comportano una notevole riduzione dei significati della lingua parlata[xxiv]. Così, i nomi di persone e luoghi che i questionari burocratici trattano come dati fissi e non negoziabili possono al contrario contenere e veicolare una serie di informazioni culturali dense, riconoscibili solo a partire dalla conoscenza del contesto d’uso.
La stessa struttura del questionario presuppone familiarità con una specifica modalità di riorganizzare l’esperienza che è presentata come standard indiscusso ma è al contrario un preciso prodotto culturale, sociale e storico; affinché possa essere compreso e quindi utilizzato correttamente dai richiedenti asilo essi dovrebbero poter condividere le risorse proprie del sistema sociale che ha prodotto il Modulo come strumento di classificazione dell’esperienza, dovrebbero cioè partecipare allo stesso “gioco linguistico”[xxv]. Quando i richiedenti asilo provengono da aree culturali in cui la socializzazione prevede altri giochi linguistici, o quando – come nel caso di Femi e di tutti i soggetti discussi nelle etnografie cui faccio qui riferimento – hanno avuto esperienze scolastiche anche molto brevi, i soggetti interrogati possono non avere alcuna familiarità con gli strumenti utilizzati; né questi vengono loro spiegati all’inizio della procedura, per diversi motivi incluso probabilmente l’assunto indiscusso della loro universalità.
La lista di domande relative al percorso di viaggio e allo svolgersi della fuga segue, ad esempio, un ordine cronologico per sequenze temporali rigide, dove ad ogni luogo nominato corrisponde una data di arrivo e di partenza e ad ogni spostamento una indicazione di durata. Come il lavoro etnografico di Malkki aveva mostrato, e come riproposto dalle recenti etnografie, la ricostruzione narrativa delle storie di fuga dei richiedenti asilo scivola sovente tra tempi passato, presente e indefinito; è inoltre fortemente ancorata al qui e all’oggi come punto di partenza della narrazione; e infine segue traiettorie spaziali oltre che temporali. Sono soprattutto i luoghi, piuttosto che le date, a scandire le tappe del viaggio e con essi tutti gli eventi, le persone e le esperienze che restano ancorati agli spazi nei quali si sono verificati. Così per esempio, nel caso del giovane ruandese richiedente asilo nel Regno Unito di cui tratta il recente saggio di Blommaert (2009), il periodo di violenze subite in prigione è indissolubilmente legato alla morte per tortura di un altro ragazzo recluso, un particolare sul quale il narratore ritorna costantemente. E il primo viaggio in mare di Femi dalla Libia verso l’Italia – che l’intervento della marina maltese dirotta verso Malta – non è separabile dalla morte in mare di Zainab, la ragazza con cui era fuggito dalla Nigeria per essere stati condannati insieme alla lapidazione per relazione illecita, e che aspettava un bambino da lui. In entrambi i casi, un determinato luogo è presentato dal narratore come un particolare centrale della storia e della propria esperienza di fuga perché identifica lo spazio all’interno del quale si è verificato un evento indelebile alla memoria, e che è recuperato retroattivamente come parte essenziale della stessa richiesta di protezione. Perché non si può che fuggire da un luogo nel quale si viene torturati a morte in prigione; perché Zainab e il suo bambino non sarebbero morti se non fossero stati costretti a fuggire da una condanna a morte. Si tratta di esperienze che non vengono acquisite come fatti, e nella determinazione finale dello status questi elementi non trovano spazio: del ragazzo morto in prigione non resta alcuna traccia nel riassunto scritto considerato dalla commissione giudicatrice britannica, così come la perdita degli affetti più cari non costituisce motivo oggettivo di richiesta di protezione poiché intervenuta dopo la fuga.
Nel processo di trascrizione all’interno di moduli e questionari standard è questo il rumore di fondo, il dettaglio non rilevante per i funzionari che mettono in atto il procedimento amministrativo, e che per ciò scompare dalle scritture finali utilizzate per determinare lo status. La selezione di ciò che è opportuno trascrivere comincia evidentemente ancora prima, quando durante il colloquio funzionario e interprete guidano (o incalzano) il narratore con frasi come “andiamo con ordine” o “seguiamo la procedura”, che riportano la storia dentro i binari previsti potenzialmente impedendo la possibilità di enunciare determinati eventi dissonanti.
D’altro canto alcuni eventi, figure o luoghi sono al contrario considerati centrali per lo svolgimento della procedura. Mi riferisco alle domande di controllo o check questions, che a livello transnazionale presentano elementi ricorrenti e simili (il nome del presidente dello Stato, il fiume che attraversa la regione, la strada principale della città) immaginati come informazioni che qualsiasi cittadino di una determinata nazione deve necessariamente conoscere, e quindi utilizzati per verificare veridicità e credibilità della storia e del narratore. Le parti del colloquio che insistono su questi punti sono potenzialmente le meno chiare ai richiedenti stessi, che in molti casi non sanno esattamente cosa aspettarsi nei primi incontri istituzionali e non sono comunque preparati a sostenere ciò che appare loro come un test di geografia o politica che insinua da subito dubbi sulla loro credibilità (Jacquemet 2005). È attraverso questi passaggi che un’interazione presentata e iniziata come un colloquio assume progressivamente i contorni di un interrogatorio. Maryns per esempio riporta un caso di colloquio in cui il funzionario domanda alla richiedente asilo di esprimere la distanza tra la città di origine e la capitale dello Stato in termini di tempo oppure miglia; si tratta di una minore con un basso livello di scolarizzazione, che tenta ugualmente di rispondere ad una richiesta complicata descrivendo il percorso e nominando i villaggi che si devono attraversare per arrivare da Bo a Freetown. Ma il funzionario non conosce in tale dettaglio la geografia del luogo né ha tempo per verificarne la correttezza, ed alzando la voce incalza l’intervistata per ottenere dati numerici verificabili: ore, miglia. Analogamente, il rigetto del ricorso inoltrato a seguito del diniego dello status di rifugiato dal ragazzo ruandese nel Regno Unito è motivato dal Ministero dell’Interno, tra le altre cose, dal fatto che durante i colloqui il richiedente sarebbe risultato incapace di nominare la Banca principale, i nomi delle strade o la geografia del paese, elementi che ci si aspetta qualsiasi cittadino del Ruanda conosca. Ricostruendo nel dettaglio una intricatissima storia di malintesi e omissioni, Blommaert nota a questo proposito che il ragazzo aveva abbandonato la zona su cui viene interrogato a seguito di eventi incredibilmente traumatici, all’età di 5 anni[xxvi].
Le modalità dell’interazione burocratica durante i primi colloqui e i processi di ritestualizzazione delle narrazioni – all’interno di un genere specifico come il modulo standard e riservati a specifici gruppi professionali – riducono ulteriormente la possibilità di comprendere storie che sono indubbiamente difficili da decifrare e che vengono definite non a caso nella letteratura come frammentate, interrotte. Si tratta di storie potenzialmente molto complesse, ma che finiscono per apparire caotiche o confuse anche a seguito degli interventi di trascrizione e circolazione cui vengono sottoposte durante la procedura, che rendono molto più esili le possibilità dei richiedenti asilo di essere creduti. L’operazione di inscrizione avviene seguendo una “ideologia del testo fisso” in base alla quale la differenza tra il testo orale originale e le sue versioni scritte è ritenuta minima, dato che un testo “proceduralmente corretto” appare come un sistema trasparente di segni. In questo senso, l’intera traiettoria testuale è attribuita al richiedente asilo che è considerato l’autore responsabile del documento finale; ciò nasconde le forme di slittamento del discorso attraverso “domini di (in) testualizzazione autorevole che sono molto lontani dal controllo del richiedente asilo: quando diciamo ‘la storia del richiedente asilo’ in realtà ci riferiamo a questa traiettoria testuale totale della narrativa”; il risultato di questa traiettoria testuale è una mera “possibilità” di giustizia[xxvii].
Ritengo possibile suggerire che il grande rilievo attribuito alla narrazione in sé (tanto nella procedura che nella letteratura sui processi di asilo) contribuisca a nascondere i passaggi attraverso i quali le storie vengono rimaneggiate da più mani e più autori al fine di estrarne fatti oggettivi e comparabili, oscurando di fatto l’equivalente peso del testo scritto che ne risulta. Attraverso le varie tappe impiegate per setacciare le storie alla ricerca di prove della loro veridicità e coerenza, e per renderle leggibili, queste vengono lavorate e ricostruite come testi scritti, attraverso operazioni di omissione, elisione, manipolazione e fraintendimento che tagliano via significatività e spessore. Non intendo suggerire al contrario una intrinseca coerenza o trasparenza originaria che andrebbe così perduta; né negare il ruolo che trauma e sofferenza, oppure finzioni e strategie creative, giocano nella costruzione da parte dei richiedenti asilo stessi di narrazioni comunque difficili da decifrare; né infine sottintendere che il giudizio in tali contesti sia operazione semplice. Mi sembra piuttosto utile mostrare, come le più recenti etnografie consentono di indicare, che la pretesa di trasparenza della procedura, di oggettività ed equità tra casi attribuita agli strumenti utilizzati e rivendicata nelle decisioni finali a motivare le stesse, sia al contrario uno degli elementi che contribuisce a rendere tali narrazioni opache e incoerenti.
Anche nel caso di Femi l’insistenza sui luoghi e sui nomi delle strade ha uno spazio non secondario nel primo colloquio. In quella circostanza particolare rilievo è stato dato al luogo dove lavorava, la strada dove si trovava l’officina dello zio presso il quale era impiegato come meccanico, ed anche in quel caso i nomi e le indicazioni da lui fornite non potevano essere controllate né sembrano essere state comprese. Femi menziona infatti una “First Bank” che, ad un rapido controllo sulla rete, si rivela essere la filiale di una banca di un certo rilievo presente effettivamente nella strada da lui indicata, ma che nel Modulo finale compare come parte integrante dell’indirizzo stesso, mentre il nome dello Stato è scambiato per il nome della città, e quest’ultima non compare in nessun punto del questionario. Si tratta di un altro esempio di quelle “informazioni inaccurate” che, una volta entrate nel circuito della testualizzazione possono compromettere l’esito della stessa procedura (Maryns 2006, 62), soprattutto quando sommate tra loro. Durante il colloquio in questura, tale insistenza su particolari per lui poco rilevanti risulta moralmente ancora più pesante quando si inscrive la sua vicenda personale nel quadro nazionale e transnazionale da cui infine l’esito dipende. Perché alla fine del lungo, faticoso e doloroso colloquio accadono altre due cose. In primo luogo, il pubblico ufficiale comunica all’operatore che ha accompagnato Femi, che dovrà “far scattare l’art.10”[xxviii]. Si riferisce con questo a quanto previsto dal noto “pacchetto sicurezza” in base al quale chi entra senza documenti in Italia (è evidentemente il caso dei moltissimi richiedenti asilo che riescono a fuggire in circostanze improvvise ed impreviste) deve essere denunciato comunque come clandestino, anche qualora si presenti spontaneamente alle autorità per chiedere protezione. In secondo luogo, la funzionaria ricorda scuotendo la testa che Femi “è un Dublino” e, come annunciato, verrà di li a poco ricollocato in uno dei CARA sparsi sul territorio nazionale, all’interno dei quali l’accesso all’assistenza legale è più difficile e dove i tempi per l’eventuale ricorso sono dimezzati, spezzando infine i fragili legami sociali appena attivati sul posto. Nel gergo burocratico, Dublino[xxix] si riferisce tra l’altro, al caso in cui un soggetto sia entrato nell’Unione Europea attraverso un paese diverso da quello dove presenta domanda di protezione, o che abbia inoltrato una precedente richiesta di asilo in altro Stato dell’Unione Europea: in entrambi i casi è il primo paese che risulta competente, ed è lì che il richiedente verrà reinviato. E’ questa più ampia cornice transnazionale, e non l’accertamento dell’identità di Femi Okebiyi o la coerenza della sua storia, e nemmeno la sua capacità di dimostrarne la veridicità, che deciderà infine l’esito della sua richiesta di protezione.
[i] Sulla relazione tra le due discipline si veda Cannada Bartoli (2009).
[ii] United Nations High Commissioner for Refugees – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) – è creato nel 1951 in concomitanza con la ratifica della Convenzione di Ginevra e segna il passaggio della visione dell’asilo politico da questione militare a tema umanitario.
[iii] Un fenomeno che ha invece interessato maggiormente l’Europa fino agli anni ’90 con la guerra in ex-Yugoslavia e la crisi in Kosovo e che, con le attuali rivolte in Nord Africa e la guerra in Libia viene – nel momento in cui termino questo lavoro (aprile 2011) – riattivato nel discorso governativo e mediatico su scala “apocalittica”, con riferimenti ad esodi biblici e catastrofi naturali.
[iv] Per alcune differenze procedurali tra i paesi europei si veda ECRE/ELENA (2010).
[v] Rispettivamente Malkki (1995) e Zetter (2007).
[vi] Per elementi di continuità e una critica ad approcci considerati “di eccessivo relativismo” si veda Colson (2003); sulla procedura istituzionale standardizzata come elemento unificante nell’esperienza dei richiedenti asilo in Europa si veda tra gli altri Grifhorst (2000).
[vii] Nella sua tesi di dottorato, Zachary Whyte (2009, 44-51) esplora questo aspetto al fine di ridimensionare l’utilizzo delle suggestioni foucaultiane per esemplificare il potere di controllo dello Stato sui richiedenti asilo, e mostrare come lungi dall’essere assoluto e pervasivo – e pur presentandosi tale – questo sia invece limitato, parziale e strategicamente miope. Si veda ora anche Id. (2011).
[viii] Sullo slittamento da un genere all’altro tornerò in chiusura.
[ix] Si veda Beneduce (2010) per una rassegna critica sul tema e soprattutto per una proposta che prova a raccogliere “la sfida della cura” in casi di sofferenza estrema; Quaranta (2006) per una riflessione sulla sofferenza sociale e per un’utile raccolta di saggi sul tema, incluso quello in cui Paul Farmer propone tale categoria; Taliani e Vacchiano (2006) per i molti esempi di difficile traduzione di questo dibattito in interventi di cura.
[x] Per una rassegna critica di una parte della storia di questi studi – essenzialmente in linguistica e sociolinguistica – si veda Bauman e Briggs (1990); in antropologia il testo curato da Clifford e Marcus (1997), che sancisce l’importanza dello studio dei contesti di produzione dei testi etnografici come narrazioni sull’Altro, è di qualche anno precedente.
[xi] Per l’Italia un esempio importante e attento anche alla dimensione della memoria della violenza, è il progetto di ricerca multidisciplinare iniziato negli anni Novanta sulla “memoria divisa” in relazione alle stragi naziste di civili nel Nord Italia, di cui si dà conto tra l’altro in Clemente e Dei 2005. Si veda anche Dei 2005 per una rassegna critica degli studi di antropologia della violenza.
[xii] De Fina e Bayhnam (2005). Questa misura dell’agency è in certo senso anticipata nel lavoro di Erving Goffman (1968) dedicato alle forme di interazione e comunicazione in contesti istituzionali totali, che fa da sfondo a questi studi. Una etnografia delle oscillazioni tra soggettività costrette nei sistemi burocratici e creativamente reinventate, rispetto a donne richiedenti asilo in Italia, è Pinelli (2010).
[xiii] Rispettivamente Maryns (2006, 313) e Blommaert (2001, 415).
[xiv] Si veda su questo Blommaert (2001; 2009), Briggs (1997b), Jacquemet (2005), e Maryns (2006).
[xv] De Fina e Baynham (2005, 3); ma si veda già il saggio di Knudsen (1995) sulla elisione di incoerenze ed incongruità e sulla manipolazione delle storie personali da parte dei richiedenti, per tentare di ottenere lo status di rifugiati.
[xvi] Come la letteratura dimostra, l’arbitrarietà di tempi ed esiti della procedura è una caratteristica ricorrente nella percezione dei richiedenti asilo in Europa.
[xvii] Sul tema della circolazione dei testi tra contesti in condizioni di disordine e conflitto rimando a Briggs (1997a).
[xviii] I Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo sono stati creati nel 2008 a seguito dell’adozione della Procedura Direttive 2005/85/EC e sostituiscono i precedenti Centri di Identificazione o CID: si tratta di strutture di grandi dimensioni solitamente collocate lontano dai centri abitati e senza alcun collegamento con il tessuto economico e sociale circostante. Lo SPRAR è il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati; istituito ai sensi dell’art. 32 della Legge 189/02 e affidato dal Ministero dell’Interno all’ANCI per convenzione, si compone attualmente di 138 progetti distribuiti in 123 amministrazioni locali (essenzialmente comuni), funziona su base volontaria ed i comuni che partecipano al Sistema si impegnano ad implementare progetti di accoglienza e integrazione per diverse tipologie di persone (richiedenti asilo, minori non accompagnati, soggetti vulnerabili) mediante gestione diretta o delega a soggetti locali, ed utilizzando le risorse presenti sul territorio (personale delle amministrazioni locali, Ong e associazioni di volontariato). Per un maggior dettaglio si veda SPRAR – Cittalia (2010).
[xix] Ringrazio Jane Cowan per avere discusso con me la possibilità di cogliere la circolazione di ideologie, saperi e credenze tra globale e locale rivolgendo l’analisi al ruolo di mediazione svolto dai soggetti istituzionali nella loro relazione con i richiedenti asilo. La risposta allo stesso problema che emerge dal dialogo tra George Marcus e Paul Rabinow sembra andare in altra direzione, proponendo di ridefinire il posto dei soggetti “consueti” dell’etnografia (persone qualunque, marginali, subalterni, migranti e rifugiati compaiono come esempi) a partire dal dialogo con i “truth-claimers”: esperti o membri dell’élite intellettuale che hanno l’autorità di definire “i vettori scientifici, legali o finanziari” di affermazioni di verità che in vari punti intercettano le vite delle “persone normali” (Rabinow e Marcus 2008, 73-95)
[xx] Oltre a Ravenna (Sorgoni 2011a; 2011c) la mia ricerca è tutt’ora in corso a Forlì e Bologna (Sorgoni 2011b); i luoghi dell’osservazione sono: i commissariati per la prima richiesta di asilo, le Aziende di servizi alla persona e i Centri di servizi per stranieri per le pratiche di accoglienza e accompagnamento attraverso l’iter amministrativo e legale, i centri di residenza dei richiedenti stessi, le associazioni di volontariato per i corsi di lingua italiana. La ricerca è resa possibile grazie all’interesse mostrato dai rispettivi sindaci, assessori e funzionari comunali, ed è agevolata dalla disponibilità generosa di operatori e volontari, e naturalmente dei richiedenti asilo: a tutti loro rivolgo un sincero ringraziamento.
[xxi] Poiché più volte nel colloquio l’interprete esprime proprie convinzioni sull’Africa come luogo definito per difetto, il dubbio qui avanzato identifica un eccesso impensabile persino in condizioni di tale deprivazione e mancanze, così rimarcando la normalità di queste ultime.
[xxii] Possibilità che potrebbero esistere: in yoruba Êfê vuol dire Festicciola, momento di gioia tra amici; Àfè significa Godimento; Ofè è Offerta. Ringrazio Franck Viderot per queste indicazioni.
[xxiii] Ciò nel caso specifico è complicato dal fatto che l’interprete sta traducendo un nome proprio yoruba ma lo recepisce come se fosse un termine inglese.
[xxiv] Questo tema rimanda anche al dibattito sugli universali cognitivi, per una discussione del quale si veda Dei e Simonicca (2008).
[xxv] Sui sistemi educativi della scuola “moderna” – ad es. questioning e sequenza domanda/risposta/ valutazione o verifica – come “‘gioco linguistico’ ad alto modellamento sociologico e culturale”, si veda Simonicca 2011, p.35 e ss. Si veda ancora Cuturi (2010) per un riferimento alla specificità culturale di generi come intervista, questionari e test; Fasulo e Pontecorvo (1999) per uno studio del nesso tra regole linguistiche e comprensione della società nella prima socializzazione scolastica e familiare. A quest’ultimo lavoro mi sono ispirata per le convenzioni di trascrizione dei dialoghi.
[xxvi] Maryns (2006, 211 e ss.); Blommaert (2009, 418 e ss).
[xxvii] Cfr. Blommaert (2001, 439) (corsivo mio), che si ispira al saggio di Charles Briggs (1997b) sulle traiettorie testuali processuali in un contesto segnato da potenti dislivelli di potere su base etnica. Come proposto nel volume di Alessandro Duranti (2001), traduco con “(in)testualizzazione” il concetto di entextualization introdotto da Bauman e Briggs (1990).
[xxviii] Si tratta dell’art. 10bis L.94/09 che introduce il reato di clandestinità per chi giunge irregolarmente in Italia, in molti casi applicato illogicamente anche ai richiedenti asilo che presentano domanda di protezione ma risultano privi di adeguati titoli di viaggio o documenti di ingresso.
[xxix] Il Regolamento 343 del 18/02/2003 (o Dublino II) – approvato in seguito alla Convenzione di Dublino del 1990 – stabilisce i criteri di determinazione dello Stato membro responsabile dell’esame di una domanda di asilo.
Bibliografia
Asad T. 1997, Il concetto di traduzione culturale nell’antropologia sociale britannica, in Clifford J., Marcus G. (a cura), Scrivere le culture. Poetiche e politiche dell’etnografia, Meltemi, Roma, pp. 199-230.
Bauman R., Briggs C. L. 1990, Poetics and Performance as Critical Perspectives on Language and Social Life, «Annual Review of Anthropology», 19, pp. 59-88.
Beneduce R. 2010, Archeologie del trauma. Un’antropologia del sottosuolo, Laterza, Roma-Bari. Blommaert J. 2001, Investigating narrative inequality: African asylum seekers’ stories in Belgium, «Discourse & Society», 12(4), pp. 413-49.
Blommaert J. 2009, Language, Asylum, and the National Order, «Current Anthropology», 50(4), pp. 415-41.
Bohmer C., Shuman A. 2008, Rejecting Refugees. Political Asylum in the 21st century, Routledge, London and New York.
Bourdieu P. 1988, La parola e il potere. L’economia degli scambi linguistici, Guida, Napoli. Briggs C. L. 1997a, Introduction: from the Ideal, the Ordinary, and the Orderly to Conflict and Violence in Pragmatic Research, «Pragmatics», 7(4), pp. 451-59.
Briggs C. L. 1997b, Notes on a “Confession”: on the Construction of Gender, Sexuality, and Violence in an Infanticide Case, «Pragmatics», 7(4), pp. 519-46.
Cannada Bartoli V. 2009, Antropologia e linguistica, Carocci, Roma.
Clemente P., Dei F. (a cura) 2005, Poetiche e politiche del ricordo. Memoria pubblica delle stragi nazifasciste in Toscana, Carocci, Roma.
Clifford J., Marcus G. (a cura) 1997, Scrivere le culture. Poetiche e politiche dell’etnografia, Meltemi, Roma.
Collins J. 2005, Afterword: ‘Story, Place, Encounter’, in De Fina A., Baynham M. (a cura) Dislocations/Relocations. Narratives of Displacement, St. Jerome Publishing, Manchester and Northampton, pp. 242-51.
Colson E. 2003, Forced Migration and the Anthropological Response, «Journal of Refugee Studies», 16(1), pp. 1-18.
Colson E. 2004, Displacement, in Nugent D., Vincent J. (a cura) A Companion to the Anthropology of Politics, Blackwell Publishing, Malden, Oxford and Victoria, pp. 107-20.
Cuturi F. 2010, Parole, in Pennacini C. (a cura) La ricerca sul campo in antropologia. Oggetti e metodi, Carocci, Roma, pp. 125-86.
De Fina A., Baynham M. 2005, Introduction, in Id. (a cura) Dislocations/Relocations. Narratives of Displacement, St. Jerome Publishing, Manchester and Northampton, pp. 1-10.
Dei F. 2005, Descrivere, interpretare, testimoniare la violenza, in Id. (a cura) Antropologia della violenza, Meltemi, Roma, pp. 7-75.
Dei F., Simonicca A. (a cura) 2008, Ragione e forme di vita. Razionalità e relativismo in antropologia, Franco Angeli, Milano.
Duranti A. (a cura) 2001, Culture e discorso. Un lessico per le scienze umane, Meltemi, Roma.
ECRE/ELENA 2010, Survey on Legal Aid for Asylum Seekers in Europe, October 2010, http://www.ecre.org/resources/Policy_papers.
Fabian J. 1991, Accident and Method in the Study of Intercultural Communication: Colonial Description of Swahili in the Former Belgian Congo, in Blommaert J., Verschueren J. (a cura) The Pragmatics of Intercultural and International Communication, John Benjamins Publishing, Amsterdam and Philadelphia, pp. 33-50.
Farah N. 2003, Rifugiati. Voci della diaspora somala, Meltemi, Roma.
Fassin D., D’Hallouin E. 2007, Critical Evidence: the Politics of Trauma in French Asylum Policies, «Ethos», 35(3), pp. 300-29.
Fasulo A., Pontecorvo C. 1999, Come si dice? Linguaggio e apprendimento in famiglia e a scuola, Carocci, Roma.
Goffman E. 1968, Asylums. Le istituzioni totali: meccanismi della esclusione e della violenza, Einaudi, Torino.
Grifhorst P. 2000, Power, medical care, and resistance in Dutch centres for asylum seekers, in Goździak E. M., Shandy D. J. (a cura) Rethinking Refuge and Displacement, Selected Papers on Refugees and Immigrants, vol. VIII, AAA, Arlington VA, pp. 223-49.
Jacquemet M. 2005, The Registration Interview. Restricting Refugees’ Narrative Performance, in De Fina A., Baynham M. (a cura) Dislocations/Relocations. Narratives of Displacement, St. Jerome Publishing, Manchester and Northampton, pp. 197- 220.
Knudsen J. C. 1995, When Trust is on Trial: Negotiating Refugees Narratives, in Daniel V. E., Knudsen, J. C. (a cura), Mistrusting Refugees, Berkeley, University of California Press, pp. 13-35.
Kobelinsky C. 2010, L’accueil des demandeurs d’asile, Éditions du Cygne, Paris.
Malkki L. 1995, Refugees and Exile: from “Refugee Studies” to the National Order of Things, «Annual Review of Anthropology», 24, pp. 495-523.
Malkki L. 1996, Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and Dehistoricization, «Cultural Anthropology», 11(3), pp. 377-404.
Maryns K. 2006, The Asylum Speaker. Language in the Belgian Asylum Procedure, St. Jerome Publishing, Manchester and Northampton.
Merry S. E. 2006, Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping the Middle, «American Anthropologist», 108(1), pp. 38-51.
Ochs E., Capps L. 1996, Narrating the Self, «Annual Review of Anthropology», 25, pp. 19-43.
Pinelli B. 2010, Soggettività e sofferenza nelle migrazioni delle donne richiedenti asilo in Italia, in Ribeiro Corossacz V., Gribaldo A. (a cura) La produzione del genere. Ricerche etnografiche sul femminile e sul maschile, Ombre Corte, Verona, pp. 135-55.
Quaranta I. (a cura) 2006, Introduzione «Annuario di antropologia. Sofferenza sociale», 6(8), pp. 5-16.
Rabinow P., Marcus G. con Faubion J. D. e Rees T. 2008, Designs for an Anthropology of the Contemporary, Duke University Press, Durham and London.
Simonicca A. 2011, Questioni di metodo, in Id. (a cura) Antropologia dei mondi della scuola. Questioni di metodo ed esperienze etnografiche, CISU, Roma, pp. 15-164.
Sorgoni B. 2011a, Alcune note etnografiche su politiche istituzionali e pratiche sociali nella gestione dei richiedenti asilo, in Faldini L., Pili E. (a cura) Saperi antropologici, media e società civile nell’Italia contemporanea, CISU, Roma, pp. 255-66.
Sorgoni, B. 2011b, Storie dati e prove. Il ruolo della credibilità nelle narrazioni di richiesta di asilo, «Parolechiave», 46, pp. 115-33.
Sorgoni B. (a cura) 2011c, Etnografia dell’accoglienza. Rifugiati e richiedenti asilo a Ravenna, CISU, Roma.
SPRAR – Cittalia (a cura) 2010, Rapporto annuale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Anno 2009-2010, Roma.
Taliani S., Vacchiano F. 2006, Altri corpi. Antropologia ed etnopsicologia delle migrazioni, Edizioni Unicopli, Milano.
UNHCR 2010, 2009 Global Trends. Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced, Stateless Persons, Geneve.
UNHCR s.d., Intervistare i richiedenti asilo, Roma.
Whyte Z. 2009, In Process: an Ethnography of Asylum-Seeking in Denmark, D. Phil. Dissertation, Institute of Social and Cultural Anthropology, University of Oxford.
Whyte Z. 2011, Miopia, incertezza e potere nel sistema d’asilo danese, in Sorgoni B. (a cura) Chiedere asilo in Europa. Confini, margini e soggettività, in «Lares», LXXVII(1), pp. 23-52.
Zetter R. 2007, More Labels, fewer Refugees: Remaking the Refugee Label in an era of Globalization, «Journal of Refugee Studies», 20(2), pp. 172-92.