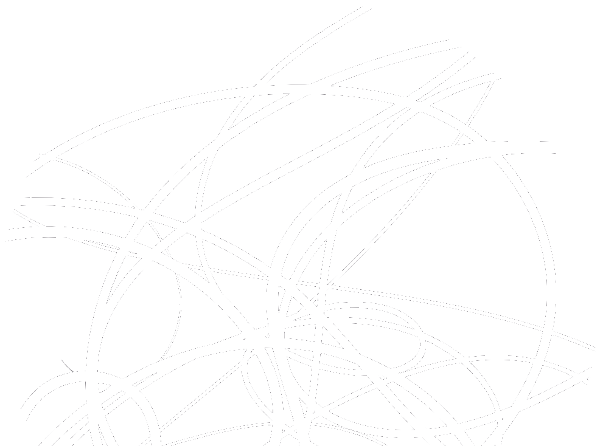E noi? Dov’eravamo e dove siamo adesso. Questa la domanda che ultimamente macina nella mia mente e che sempre più spesso raccolgo dalle voci di colleghe e colleghi. Quel noi, infatti, chiama in causa in primo luogo chi ha lavorato e ancora lavora nel campo dell’accoglienza ai cosiddetti profughi: gli e le operatrici sociali. Ma sarebbe stupido limitarsi a quello specifico settore lavorativo. Quel noi vorrebbe chiamare in causa tutte quelle persone che a vario titolo, dall’associazionismo alla militanza passando per il grande e opaco terzo settore, hanno operato al fianco e a sostegno dei profughi. Ma ancora non basta. Quel noi vorrebbe interrogare sulle proprie responsabilità intellettuali, amministratori, uomini e donne, tutta una società che ha lasciato o, peggio, ha attivamente collaborato affinché si affermasse l’attuale situazione politica.
Domanda urgente e vana, per cui tanto vale tornare a quel noi che mi riguarda più da vicino. Per esser chiaro, l’attuale governo con le sue scellerate politiche non è che l’ultimo – ultimo in termini temporali, ché al peggio non c’è mai fine – momento di un continuum storico-politico che ha cause lontane e complesse. Ma quello attuale è sicuramente il momento più critico e, come in tutte le crisi, si è costretti ad entrare nel vivo e a dover far i conti con le contraddizioni più cocenti. Noi, operatori e operatrici sociali, dov’eravamo quando fu emanato il famoso decreto risalente al febbraio 2011, dall’allora governo Berlusconi, con cui fu istituita l’Ena (Emergenza Nord Africa), punto di snodo e di svolta per le future politiche migratorie nazionali? Probabilmente, la maggior parte dei miei attuali colleghi e colleghe iniziava appena ad affacciarsi al mondo della migrazione, me compreso. Di lì in poi, col susseguirsi delle emergenze “dovute all’eccezionale afflusso di migranti” (Mare Nostrum, Triton, Emergenza Sbarchi, etc.) l’accoglienza è diventata uno dei settori lavorativi in cui il tasso d’occupazione è aumentato esponenzialmente, in controtendenza al trend generale della nazione. Tuttavia, si trattava e ancora si tratta di una forza lavoro peculiare, messa in una posizione liminale a ricoprire un ruolo strategico tra inclusione, controllo e disciplinamento. Eppure, chi ha mai sentito parlare dell’operatore al di fuori del perimetro assai delimitato degli addetti e addette ai lavori? Più che altro, il mainstream politicamente orientato ha piuttosto creato dei concetti armati quali “i 35 € al giorno per migrante”, “il business dell’accoglienza” o, nel migliore dei casi, “il governo dei flussi migratori”. E noi, mentre questa retorica acquisiva sempre più la forza del senso comune, dov’eravamo? Assunti per la necessità istantanea di mano d’opera e di una fonte di reddito, avvicinandoci sempre più al modello di lavoro proprio al mondo della logistica, just in time e to the point, dove il fabbisogno della forza lavoro dipende dalla quantità delle merci da smistare, siamo stati assorbiti, ingabbiati e incapsulati nella bolla dell’accoglienza, dove il tempo accelerato dell’emergenza ha determinato pesantemente le condizioni di lavoro, mettendo in forte tensione corpi e menti. Certo, non solo il tempo: la divisione del lavoro, la frammentazione delle équipe e la distanza geografica tra i luoghi di lavoro, la crescente gerarchizzazione e aziendalizzazione costituiscono altri elementi fondamentali per capire noi dov’eravamo. Abbiamo probabilmente scontato il fatto di essere una categoria lavorativa appena nata, quasi del tutto inesperta e con poca o alcuna coscienza non solo professionale ma sindacale, catturati in quelle economie morali in cui la qualità e il riconoscimento del lavoro svolto non si misuravano attraverso un’adeguata forma contrattuale e annessa remunerazione ma tramite un più sottile e pericoloso salario: il bene. Per cui poco importava quanto si lavorava, e ancora si lavora, se si fanno ore in più non segnate, se si è sotto inquadrati, sotto remunerati, messi sotto pressione o ricatto. Ciò che ci riempiva – di certo non le tasche – era il bene, magari riconosciuto nel volto della persona che si aveva in carico. Non ci siamo accorti intanto che il ministro dell’Interno Marco Minniti andava in Nord e Centro Africa a siglare accordi con i Paesi da cui provenivano o transitavano una buona parte dei profughi; non ci accorgevamo che, conclusasi l’interpretazione umanitaria del governo dei flussi, prendeva prepotentemente campo quella più dichiaratamente militare e securitaria; magari ci siamo indignati nell’ascoltare le voci e gli sguardi razzisti dei e delle cittadine comuni rivolti verso “i nostri beneficiari”; abbiamo fatto finta che tutto potesse andare avanti, che il nostro lavoro e passione avessero senso ed efficacia, voltando lo sguardo a quanto invece si stava verificando e che ora ci mette di fronte al rischio concreto della perdita del lavoro e di un’esponenziale clandestinizzazione ed emarginazione dei migranti. Noi, in tutto ciò, dov’eravamo?
E dov’erano le amministrazioni comunali, le associazioni, le cooperative a cui era stata demandata la gestione dell’accoglienza? Quale lungimiranza politica ed occupazionale ha animato le loro scelte, scelte di cui ora sono i primi a doverne misurare le conseguenze? Mi chiedo se quel logorante tatticismo politico, quel continuo e sfibrante riposizionamento, quella diplomatica, riottosa e cieca concorrenza non siano stati anch’essi funzionali alla produzione dell’attuale situazione politica. E certo trovo una distopica illusione voler adesso investire tutto nel totem salvifico della “comunicazione”, come se ancora una volta una “buona” comunicazione possa arginare o cambiare i termini del problema, che è assolutamente politico. Né far indossare giubbini catarifrangenti a profughi mentre puliscono parchi pubblici, né progettare bandi dall’esplicativo titolo “i richiedenti asilo per la città”, né d’altra parte rivendicare una presunta qualità e valore sociale del nostro lavoro può cambiare di un millimetro i rapporti di potere e invertire l’ormai dominante discorso comune. No, quel che in questi anni è mancato, a tutti e tutte noi, credo sia stato il conflitto, la lotta, innanzitutto a partire da noi stessi, per noi stessi. Allora, noi dov’eravamo? Nel sogno di una cosa. “Il mondo ha il sogno di una cosa, del quale deve solo prendere coscienza per averla veramente”, scriveva Karl Marx all’età di venticinque anni. Forse, noi siamo ancora troppo giovani. Ma se la crisi attuale ha pure un’utilità, questa è nel farci prendere coscienza su dove siamo noi, ora.