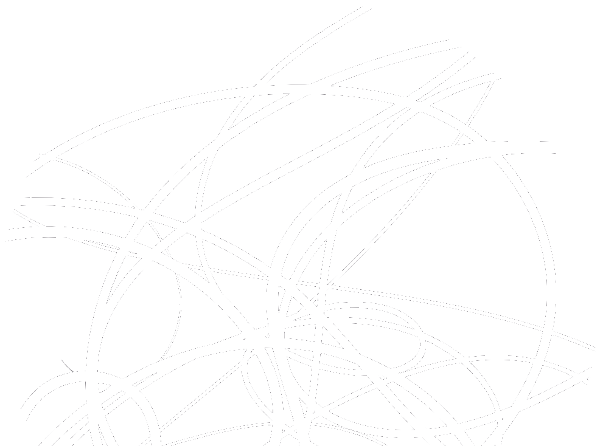Quando ho letto le pagine che seguono del medico e antropologo francese Didier Fassin, da una parte mi sono tornate in mente le immagini terribili delle ondate di violenza xenofoba a Johannesburg, nel 2015, per mano di neri nei confronti di altri neri; di sudafricani disoccupati nei confronti di immigrati, rifugiati, richiedenti asilo e “clandestini” (provenienti per lo più da Zimbabwe, Mozambico, Zambia, ma anche Nigeria, Ghana, Eritrea, Etiopia, Bangladesh e Pakistan) accusati di rubare loro il lavoro. Dall’altra, la ricostruzione che Fassin fa, in Le vite ineguali (Feltrinelli 2019), della condizione di vita degli stranieri in Sudafrica mi sembra abbia molti tratti di somiglianza – impantanamento burocratico, sfruttamento lavorativo, occupazione di alloggi abbandonati, clandestinità, ostilità della popolazione locale – con la situazione dell’accoglienza e del dopo-accoglienza italiani (eccetto forse per i numeri e le forme estreme di violenza che speriamo l’Italia riesca ad evitare).
Ma oltre ai tratti di somiglianza dell’oppressione che gli stranieri africani subiscono in molte parti del mondo, l’altro elemento che colpisce delle analisi di Fassin è il margine di imprevedibilità e autonomia che le “forme di vita straniera” si prendono (e che non bisogna smettere di accordare loro) anche nelle situazioni più estreme. C’è vita oltre l’accoglienza, dicevano alcuni sarti congolesi alla scorsa edizione delle “Strade del mondo”; sotto la forma, la vita persiste, scrive, in un senso analogo, l’antropologo francese in chiusura del primo capitolo (“Forme di vita”, p. 33 e seguenti) di cui ho selezionato alcuni stralci. (Luigi Monti)
La vita forma uno strato superficiale in virtù del quale sembra che l’esistenza non possa essere diversa da come è, ma al di sotto di quella pellicola le cose spingono e urlano.
Robert Musil, L’uomo senza qualità, 1930
Nel quartiere degli affari di Johannesburg, decine di sontuosi palazzi, una volta simboli dell’opulenza sudafricana, dove le grandi aziende avevano la loro sede e le classi superiori bianche la loro residenza, sono diventati negli anni successivi alla fine dell’apartheid nel 1994 dei dark buildings, edifici abbandonati dei loro proprietari e ora abitati da occupanti illegali. Sono infatti migliaia i richiedenti asilo e gli stranieri in situazione irregolare, in maggioranza provenienti dai paesi confinanti con il Sudafrica, che vi hanno trovato rifugio in condizioni precarie tramite un affitto pagato a gang locali. Fra questi migranti, i più numerosi, dagli anni Duemila, erano gli zimbabwesi in esilio per sfuggire alla repressione del regime autoritario di Robert Mugabe e alla crisi del grano dovuta alla confisca delle terre dei coltivatori bianchi e alle sanzioni internazionali inflitte in risposta. Si stima che, in poco più di due decenni, circa due milioni di persone hanno attraversato la frontiera che separa i due paesi. Tale spostamento di massa si sommava ai flussi di popolazione venuti dall’Africa australe e centrale, da cui molti fuggivano allo stesso modo le guerre e la miseria. Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nel Duemila si contavano, fra tutte le nazionalità, quindicimila richiedenti asilo; nel 2010 erano centosettantamila; nel 2015, il loro numero raggiungeva le ottocentomila unità. Il Sudafrica si piazzava in prima posizione mondiale, con un terzo di tutti i richiedenti asilo registrati nel pianeta.
Questi numeri non si spiegano solamente con il numero di richiedenti asilo. Sono anche, se non soprattutto, la conseguenza di tempistiche estremamente lunghe per la gestione delle pratiche. Infatti, con l’arrivo della democrazia, mentre il governo sudafricano aveva preso l’impegno di rispettare il diritto internazionale ignorato dal regime precedente, soprattutto in materia di asilo, la pressione demografica dei richiedenti asilo e l’inefficacia del dispositivo burocratico attivato hanno presto portato a una congestione del sistema. Quando veniva condotta a termine, la procedura durava spesso più di cinque anni, se s’include il ricorso in appello presentato dai richiedenti in caso di rifiuto, rifiuto quasi sistematico. Durante questo interminabile periodo d’incertezza, i richiedenti dovevano rinnovare la loro richiesta ogni sei mesi in un centro d’accoglienza, dove le lunghe file d’attesa li costringevano a trascorrere più giorni dormendo in loco o a corrompere gli agenti per anticipare il loro turno. Con il passare degli anni, molti di loro, scoraggiati, finivano per rinunciare. Se la loro ricevuta era deteriorata, diventavano stranieri in situazione irregolare. Le contraddizioni dello Stato del Sudafrica, formalmente rispettoso del diritto d’asilo ma anche moltiplicatore di ostacoli al suo ottenimento, producevano allora due effetti opposti: la lentezza della procedura portava a un ingorgo che aumentava automaticamente il numero dei richiedenti, ma le pratiche dissuasive dell’amministrazione spingevano molti di loro ad abbandonare la procedura, con il risultato di una diminuzione generale del numero di persone in questione. […]
Tuttavia, più che le battaglie sulle cifre, sono le implicazioni del modo di funzionamento del sistema a essere importanti. Da una parte, la realtà della situazione suscettibile di giustificare la protezione dello Stato sudafricano non è riflessa dallo status di richiedente asilo o, a maggior ragione, di rifugiato: una percentuale ignota, ma probabilmente alta, si ritrova nella categoria di stranieri in situazione irregolare a causa delle difficoltà della procedura; all’inverso, molti di questi richiedenti ammettono di aver lasciato il loro paese per ragioni economiche e non politiche, benché in tutta evidenza siano ragioni strettamente collegate fra loro. Insomma, né le categorie giuridiche, che differenziano i richiedenti asilo dagli stranieri in situazione irregolare, né i criteri amministrativi, che distinguono i migranti dai rifugiati, paiono essere pertinenti. La realtà dell’esperienza delle persone che richiedono la protezione dello Stato sudafricano viene poco influenzata dallo status legale che viene loro riconosciuto o non riconosciuto: di fatto, i richiedenti asilo titolari di una ricevuta e gli stranieri in situazione irregolare devono affrontare problemi pressoché identici in termini di precarietà d’impossibilità di trovare un lavoro, di necessità di trovare un alloggio illegale, di animosità da parte della popolazione locale, e anche di repressione da parte delle forze dell’ordine. In fin dei conti, le tribolazioni degli uni e degli altri appaiono molto simili e li portano a mendicare o a commerciare nelle vie dei grandi agglomerati urbani, mentre non hanno praticamente nessun’altra opposizione abitativa che prendere in affitto un angolino in una township oppure gli edifici abbandonati delle citta, rimanendo sotto la minaccia costante della polizia, delle gang e degli episodi di violenza xenofoba. […]
Le diverse categorie legali nelle quali classifichiamo le persone costrette dalle circostanze a lasciare i loro paesi per cercare rifugio altrove sono quindi notevolmente porose: non solo gli stranieri sono spesso portati a passare in una categoria diversa secondo la loro erranza amministrativa, ma la rappresentazione che gli altri e loro stessi hanno del proprio status cambia a seconda dei contesti. Un uomo che attraversa la Francia avrebbe più opportunità di essere considerato un rifugiato se fosse eritreo che se fosse nigeriano ma, arrivato a Calais, verrebbe trattato come un migrante indesiderato a cui s’impedirebbe in tutti i modi di raggiungere l’Inghilterra. E che, cosa certamente rara, se egli richiedesse la protezione della Francia, diventerebbe per qualche mese richiedente asilo prima che la decisione emessa dalle autorità non lo respinga sei volte su dieci se eritreo e nove volte su dieci se nigeriano, facendo di lui un sans-papiers esposto al rischio di espulsione. Allo stesso modo, in Sudafrica, come sanno bene le donne mozambicane e congolesi, le straniere sono sempre più spesso identificate più in ragione della loro apparenza che sulla base dei loro documenti e, che siano richiedenti asilo o che si trovino in situazione irregolare, finiscono quasi sempre nel segmento inferiore e spesso illegale delle abitazioni, perché trovano risorse solo nel settore informale e spesso illecito dell’economia, diventando le vittime ideali delle angherie della polizia e di possibili pogrom. Le categorie legali sono allora allo stesso tempo importanti e insignificanti: definiscono uno status o respingono in un’assenza di status, con conseguenze potenziali in termini di diritti positivi e negativi, ma tali categorie non influenzano in nessun modo la maniera in cui le persone sono percepite e trattate nel quotidiano dalla burocrazia e dalla popolazione. Del resto, accade spesso che loro stessi ignorino la realtà della propria situazione di fronte alla legge. […]
Ma i rifugiati e i migranti conservano un certo spazio di libertà entro il quale possono dispiegare tattiche e giocare con le regole. Perfino nelle circostanze più estreme, i rifugiati e i migranti trovano soluzioni ai problemi che si pongono, negoziano accordi con gli attori locali, sviluppano forme di solidarietà, immaginano dei futuri e tentano di ricostruire una forma di vita normale. In altre parole […] la forma di vita dei nomadi forzati deriva dall’esercizio allo stesso tempo dei vincoli e del possibile, tanto fra coloro che amministrano queste situazioni quanto fra chi ne subisce le conseguenze. […]
Parlare della forma di vita di questi uomini, donne e bambini spossessati del loro paese d’origine e indesiderati nel loro paese d’accoglienza significa dare conto tanto di esperienze umane condivise quanto di contesti culturali specifici, tanto di esposizione a pericoli fisici quanto del rischio creato da misure sociali e incertezze giuridiche così come di arrangiamenti pragmatici. Ma l’insieme di vincoli implicati da queste forme di vita non basta a spiegare tutta la realtà. Come suggerito dalla frase di Robert Musil citata in esergo, sotto la superficie di quello che sembrava irrimediabilmente imporsi agli individui, vengono espresse attese e desideri e si manifestano specificità e volontà. Sotto la forma, la vita persiste.