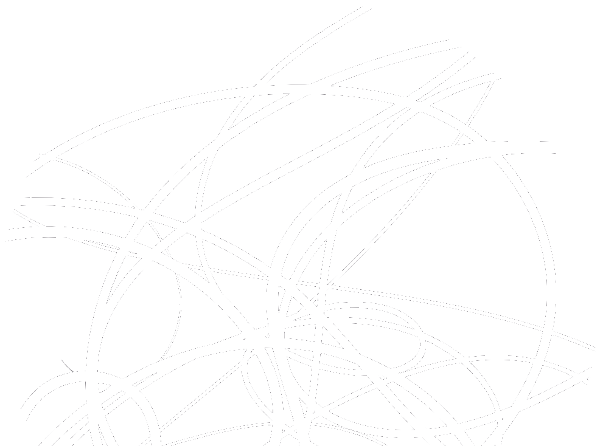Il 21 marzo 2014, l’operazione umanitaria Mare Nostrum trasformò il parcheggio antistante gli uffici del servizio comunale della città del nord dove lavoro nella banchina di Lampedusa, di Pozzallo o di tutti gli altri porti siciliani, approdo di migranti. Dopo tre giorni di viaggio incessante – soccorsi in mare, trasferiti da un’imbarcazione di fortuna a una nave della Marina Militare, spostati in pullman, in aereo e ancora in pullman – quindici giovani uomini sbarcarono nel mio ufficio. Scortati lungo tutto il viaggio da poliziotti; accompagnati da due fogli ufficiali ciascuno, sintesi formale della loro identità e del loro stato di salute. Entrarono con il loro niente in mano; più della metà senza scarpe. Nessuno con una valigia.
Qualche anno prima, nel 2011, l’Emergenza Nord Africa aveva determinato scene simili che tuttavia sembravano ancora esito di un viaggio: le persone arrivarono allora con sacchi o zaini pieni dei beni salvati dalla traversata; avevano mangiato, bevuto, dormito, alcuni sostato nei centri di prima accoglienza del sud. Allora, le tappe – seppure forzate – dell’emergenza umanitaria erano più comprensibili e i servizi di accoglienza delle città italiane si sentivano legittimati nel loro ruolo di seconda accoglienza e si riconoscevano. E noi operatori riconoscevamo i richiedenti asilo.
Tre anni più tardi – dopo il naufragio di oltre trecento persone nel Mediterraneo – la risposta organizzata dei servizi, nonostante l’esperienza precedente, appariva comunque affannata e insufficiente. Quello che serviva, in quello stesso servizio del nord, mancava. Mancavano i medici, mancava acqua e cibo, mancavano letti in cui offrire riposo. Mancava, a noi operatori dei servizi di seconda accoglienza, la consapevolezza di cosa avevamo di fronte; di come si gestisce uno sbarco di profughi sulla banchisa di Lampedusa.
Non comprendevamo che la scelta combattuta e forzata di scappare, da sempre distintiva di chi chiede protezione, stava diventando – per legge dello Stato – una condizione di progressiva passività: da richiedente ad accolto forzato. E la parola profugo stava ormai diventando l’unico modo per dire migrazioni.
I corpi di quei quindici giovani uomini, nella compostezza e nell’ordine imposto dalla fila con cui sono scesi dal pullman, rappresentavano la sintesi piena del concetto di umanità. Erano ridotti ai loro minimi termini, privi di tutto quanto vada oltre la fisicità e i bisogni primari. Gli stessi minimi termini per cui, secondo la semantica della scienza, apparteniamo allo stesso genere umano e siamo accomunati dalla stessa discendenza.
Pochi anni più tardi, proprio quell’umanità significava già altro. Tra il 2014 e il 2018 i flussi non programmati di profughi sono diventati la ragionevole conseguenza del tentativo di regolazione delle migrazioni operato dai governi italiani: chiudendo quasi del tutto i flussi d’ingresso per lavoro nel 2012, imponendo tacitamente i canali umanitari come gli unici per fare ingresso in Italia, stavamo consegnando al principio di emergenza la gestione di un fenomeno complesso, con cui facevamo i conti da almeno venticinque anni. Una regolazione emergenziale, un ossimoro.
Nel febbraio 2017, dopo un silenzio normativo di almeno dieci anni, una legge dello Stato sanciva la riforma del procedimento di richiesta della protezione internazionale. Lo stallo delle Questure, delle Prefetture e dei Tribunali, determinato dall’incremento di pratiche, esito scontato di un processo che risale al 2011, veniva risolto con una semplificazione. Abolito un grado di giudizio.
A posteriori, lo stremo fisico di quei quindici giovani adulti, che entrarono nel mio ufficio in una sera del 2014, mi è apparso come la conseguenza di una scelta politica, che ha trovato una giustificazione normativa, ossia permettere all’interno dello stesso Stato che possano esistere persone e non-persone; che queste ultime, per ragioni di politica, possano essere escluse da ogni riconoscimento o considerazione, anche normativa; che non sono dunque soggetti in sé ma a causa di un processo sociale che li esclude. Come negli anni Novanta per i clandestini, oggi i corpi dei profughi sono uno dei luoghi di azione del potere.
Appena entrati in ufficio, alcuni ancora prima di bere o magiare, tutti i quindici hanno espresso una richiesta comune, quella di telefonare a casa. Per avvisare di essere vivi, prima di tutto; per comunicare di essere in Italia: non necessariamente la meta prefigurata alla partenza; comunque in Europa. Nessuna valigia, poche scarpe, eppure tanti hanno estratto pezzi di carta, scampoli sopravvissuti al viaggio, con annotato un numero e un prefisso internazionale. Di mogli, madri e fratelli, vicini di casa o parenti lontani: chiunque, in possesso di un telefono, per attivare il passaparola necessario a diffondere la notizia dell’arrivo.
Del gruppo due erano malati, provati dalla promiscuità del viaggio in mare – dirà il medico al Pronto Soccorso – e dalla stanchezza di quello che era successo ancora prima, per giungere all’imbarco, per pagare la traversata. Ce ne siamo accorti il giorno dopo: noi, operatori della seconda accoglienza, non sapevamo leggere le malattie del viaggio. Il più vecchio e il più giovane, poi rivelatosi minorenne. Nell’attesa di comprendere la natura della malattia, il giorno dopo l’arrivo, di fronte alla difficoltà di comunicare, l’insistenza di una telefonata a casa è diventata patto di scambio con la permanenza in ospedale: un ragazzo di sedici anni ha mercanteggiato sul suo ricovero pur di confermare al fratello maggiore, in Francia, che le Petite era vivo, sano e salvo. In un ospedale in Italia, con medici e infermieri impegnati a comprendere la vera natura di esami del sangue poco chiari. Le Petite era vivo.
Tutti hanno investito in quel viaggio in virtù di quelle relazioni e attraverso di esse hanno accumulato debiti, a volte economici, più spesso emotivi. Le Petite è partito per ricongiungersi al fratello in Francia; il suo compagno di ospedale, per creare le condizioni di un ricongiungimento familiare con moglie e figli. Nessuno dei due ha raggiunto il proprio obiettivo. Li abbiamo accolti, abbiamo lavorato con loro come avremmo fatto con qualunque richiedente asilo; come avevamo imparato a fare prima che li chiamassero profughi. Ma l’accoglienza umanitaria soffoca i progetti nell’attesa: di un permesso di soggiorno sebbene provvisorio, di un’intervista in commissione, di un esito. L’Italia ha riconosciuto entrambi oggetto di protezione – dopo almeno un anno – negando nel frattempo la loro soggettività. Una protezione, quella umanitaria, che la stessa Italia può riconoscere per decreto laddove si ravvisino condizioni di emergenza; senza attese. Lo ha fatto, anni prima, con i ragazzi tunisini in fuga dalle Primavere arabe. Era una possibilità.
L’attesa, il difficile reperimento di un lavoro, la spirale di una burocrazia di massa sono diventati l’esito visibile di un sistema di accoglienza di cui lo Stato ha definito le regole senza assumersi le responsabilità degli esiti. Gli affidamenti diretti, gli atti di sottomissione alle Prefetture, gli espropri, le collocazioni forzate non hanno visto lo Stato protagonista ma gli Enti Gestori, che hanno pagato a caro prezzo la delega. Il prezzo è stato ancora più alto per quanti rappresentavano quella parte di società civile che sul mutualismo e sulla reciprocità avevano incardinato la propria storia. Anche in questo abbiamo cercato le radici del nostro disorientamento: nel nostro ruolo professionale ci era chiesto di rispondere a bisogni che conoscevamo in altra forma; nella nostra appartenenza di lavoratori ci veniva chiesto di agire in un sistema che si stava allontanando dalle proprie premesse. Quelle stesse premesse che per molti di noi avevano guidato la scelta di appartenere.
Fino all’emergenza avevamo incarnato nel lavoro di ogni giorno il migliore mescolamento tra pubblico e privato, ricontrattando quando necessario il confine e, su questo, costruendo apprendimento condiviso. Con l’emergenza, ci siamo trovati a incarnare le responsabilità di un’assenza – quella degli Enti Locali – e di una scelta – quella del mercato, che ciascuno degli Enti Gestori ha interpretato a modo proprio. Ci siamo appellati alle nostre competenze; abbiamo imparato a lavorare come se i nostri uffici fossero una banchisa dopo lo sbarco; declinando per ciascuno dei beneficiari un modello di accoglienza che li voleva massa. Alla fine abbiamo agito noi, nel rapporto con ciascuno degli accolti, le responsabilità che nessuno voleva attribuirsi.
I numeri sono stati un vincolo. I tempi sono stati un vincolo: immediati i trasferimenti e le accoglienze, dilatate le attese. Le assenze istituzionali sono state un vincolo. Le deleghe di responsabilità sono state un vincolo. Su quei vincoli abbiamo costruito possibilità.
Poi, nel 2018, lo Stato aboliva la protezione umanitaria. Aboliva l’iscrizione anagrafica. Introduceva dispositivi amministrativi che soffocano le possibilità create nei vincoli. Tra clandestino e profugo si è venuta a creare una continuità che si alimenta ancora nella retorica della paura. Clandestino e profugo diventano lo stesso modo di chiamare chi incarna il superamento del confine nazionale e ci mette di fronte alla nostra permeabilità.
La sera dell’arrivo, nel 2014, nessuno dei quindici giovani uomini si è chiesto – o ha chiesto – dove il peregrinare di tre giorni li avesse condotti, se in una città, in un paese, se vicino al mare, se al nord. Il problema del confine o del luogo non attraversa chi del superamento del confine ha fatto il proprio obiettivo, investendo aspettative individuali e familiari nel raggiungimento di un luogo altro in cui crearsi chances di vita. Dove fossero arrivati lo hanno capito nei giorni seguenti, intuendo che quella parola frequente, sentita in strada, nel centro di accoglienza dagli altri ospiti, in ufficio da noi operatori, fosse il nome della meta raggiunta. Comunque in Italia. Comunque in Europa.
Quell’Europa che lo Stato italiano ha più volte interpellato. Con cui ha disegnato road map che prevedevano confini esterni comuni: la cura di quei confini non è stata comune. Per primo lo Stato italiano ha allontanano i propri, delegandoli alternativamente alla Libia e alla Turchia. Lo ha fatto in modo economicamente oneroso. Quello stesso Stato italiano che ha trasferito in mare le leggi del sistema di accoglienza: nessuna protezione umanitaria, nessuna appartenenza, nessun riconoscimento. Ci è stato chiesto di lavorare come allo sbarco di una nave, spostando i confini davanti ai nostri uffici. Erano diventati troppo vicini e valicabili, per questo è stato necessario costruirne di nuovi, che non fossero naturali. E quello che davvero era emergenza – un salvataggio in mare – è diventato contrattabile.
La migrazione ci obbliga a specchiarci in noi stessi, ci dice come funzioniamo e come organizziamo le nostre priorità di Stato. Guardiamo le navi all’orizzonte che infrangono un limite normativo, non un confine. Ma non siamo ancora in grado di vedere tutte le gemmazioni prodotte dai confini attraversati.