La domanda sul metodo insieme a quella sull’efficacia, a lei strettamente collegata, rimane centrale, oggi come in passato, per chi si occupa di educazione e intervento sociale. Oggi come negli anni in cui io mi sono occupato di progetti educativi o di sviluppo di comunità, il discrimine, in termini di efficacia, incisività, capacità di durare nel tempo e “invecchiare bene”, passa ancora principalmente fra chi riflette sul modo del proprio agire e chi investe tutto esclusivamente sulla chiarezza (presunta) delle proprie idee e sulla forza della propria ispirazione. Fra chi si sente depositario di idee incrollabili su di sé, sui meccanismi di funzionamento della società e sul ruolo che ha in essa, e chi sa che tale lucidità non vale nulla (o al contrario può essere controproducente e pericolosa) se non accompagnata da un’altrettanta chiarezza di visione sul modo in cui metterne in pratica i principi. E non mi riferisco solo a chi in nome dei propri ideali e del disegno necessario a realizzarli sacrifica il presente e concede sconti alla moralità delle proprie azioni, ma anche alla leggerezza con cui molti ottimi gruppi educativi incontrati in questi anni rinunciano a un’attenzione al metodo, all’efficacia, alle competenze a vantaggio esclusivo di purezza di spirito, coraggio e generosità. Doti necessarie, non c’è dubbio, ma insufficienti quando si hanno obiettivi – educativi e sociali, individuali e collettivi – di cambiamento.
Il discorso sul metodo è, in senso più generale, il discorso sul rapporto tra mezzi e fini. Se i fini sono alti, elevati, nobili e puri, il metodo non può essere spurio e basso. L’importanza di questo rapporto l’abbiamo verificata spesso nel corso del Novecento, praticamente di fronte a ogni tentativo di cambiare il mondo o di inventare movimenti che fossero in grado di cambiarlo.
Attenzione al metodo non significa d’altra parte cristallizzare i propri mezzi indipendentemente dal contesto in cui vengono adottati. Tale rigidità può diventare una forma di conformismo e di incapacità a prendere atto della realtà solo per preservare la purezza del metodo. Il mondo cambia in continuazione e noi dobbiamo essere presenti a questo cambiamento.
Essere coerenti ai propri metodi significa a volte anche essere disposti a rimodularli quando si dimostrino inefficaci. Ogni volta che penso alla necessità di non fissarsi sull’ineluttabilità dei principi mi viene sempre in mente la drammatica scelta di Dietrich Bonhoeffer, pastore protestante non violento, angosciato, come Gandhi e Capitini, dal problema dell’inattività, che di fronte alla barbarie nazista decise a un certo punto di partecipare al complotto che avrebbe dovuto uccidere Hitler e che pagò col carcere e l’impiccagione. Ci sono momenti in cui la scelta peggiore non è quella dell’esercitare violenza ma il non fare niente. Se la nonviolenza si traduce solo nel mantenere la purezza di un ideale tradisce le ragioni stesse della sua essenza. Il problema vero, non sempre conciliabile con la purezza delle idee e che nessun ideale per quanto puro risolverà mai definitivamente, rimane l’efficacia delle nostre azioni all’interno della storia, individuale e collettiva, che ci è data in sorte.
Passando a un livello inferiore di astrazione, ma non per questo scollegato alle domande più elevate sul rapporto tra fini e mezzi, negli anni in cui ho lavorato come operatore sociale vigeva una sistemazione teorica molto semplice, ma di grande utilità, per la capacità che aveva di orientare il lavoro di assistenti sociali, educatori, insegnanti, psicologi e operatori sociali in genere. Una lezione che veniva dalla “scuola americana”, dal dibattito che animava gli operatori sociali più avanzati di area deweyana e da esperienze di educazione comunitaria tentate a Portorico, recepita in Italia da alcune delle scuole per assistenti sociali più vive e attive, fra cui il Cepas di Angela Zucconi.
Secondo tale approccio, i tre campi in cui andava declinato l’intervento sociale erano il case work, il lavoro sui casi individuali, il group work, il lavoro di gruppo che proprio in quegli anni mise a punto strategie e metodi di lavoro, e il community work, il lavoro sul contesto all’interno di situazioni che necessitavano di uno sviluppo comunitario.
Rispetto al case work è chiaro che uno psichiatra, un assistente sociale, un insegnante hanno strumenti e obiettivi che sono evidentemente molto diversi. Ma in tutti i casi si tratta di portare l’attenzione sulla persona che ha bisogno di essere assistita e aiutata, e di trovare il modo di farlo senza “violentarla”, rispettando le sue esigenze ma al tempo stesso aiutandola a trovare in sé e nella rete informale di cui fa parte le risorse e i grimaldelli su cui far leva per un cambiamento (si tratti di curare una malattia, di trovare un lavoro o di imparare a leggere e a scrivere).
Sul group work credo ci sia una ricchissima bibliografia che andrebbe recuperata e ristudiata, quella del cosiddetto “lavoro libero per gruppi”, alla base di tutte le esperienze e il modo di lavorare delle scuole attive e della cooperazione educativa. Infine il lavoro di comunità, quello da cui io sono stato più attratto, era fondato sulla constatazione che il lavoro educativo e sociale non potesse essere scisso dal contesto in cui avveniva e che, soprattutto nelle aree di sottosviluppo che punteggiavano l’Italia alla fine della guerra, solo intervenire sul contesto permettesse processi di liberazione ed emancipazione anche individuali. Formidabile centro di elaborazione e diffusione di questo modo di lavorare divenne il gruppo di “Comunità” di Adriano Olivetti.
Oltre all’attenzione al ben fare e alle iniziative di gruppo in quegli anni di grande fermento vanno ricordate altre tensioni che si muovevano sotterraneamente e cercavano di influenzare la società e di portare al suo interno iniezioni di relazioni comunitarie sperimentate in prima persona.
Alcune di queste presero forma in un paio di limpide iniziative che animò Aldo Capitini. Due istituzioni piccolissime e iperminoritarie, finite nel giro di pochi anni, ma che indicarono una direzione importante a chi, allora come oggi, si interrogava sul ruolo delle minoranze attive. I Cos, Centri di orientamento sociale, un esperimento di partecipazione e di decentralizzazione del potere in cui gruppi di cittadini incontravano gli amministratori locali per discutere insieme a loro problemi che li riguardavano direttamente e questioni di interesse collettivo. Di fatto delle forme di democrazia avanzatissima e nello stesso tempo antichissima, che si rifacevano esplicitamente alla “piazza” della polis greca. La piazza che era stata una delle basi del potere demagogico dei papi, degli imperatori e da ultimo del Duce, la piazza degli scontenti, a cui si rivolgevano i dittatori, che durante il ventennio aveva espresso un ideale di rivolta senza finalità precise, tornava ad essere per gli animatori dei Cos, uno spazio di democrazia diretta: il popolo che si raduna e discute di tutto, all’aperto, con i suoi rappresentanti politici. La stessa piazza che seguiva passivamente un capo, una guida, un leader, ora si riuniva per prendere decisioni che riguardavano la sua vita ordinaria: l’ideale dell’agorà ateniese. Tutto questo ha avuto corso, in Toscana e Umbria, per poco più di un anno: Perugia, Gubbio, Assisi, Firenze e pochi altri centri in cui i Cos tentarono di alimentare il tessuto democratico di un’Italia ancora profondamente fascista, non solo nei contenuti politici, ma anche nei modi di discuterli.
La seconda delle istituzioni capitiniane, se possibile ancor più radicale e minoritaria era il Cor, Centro di orientamento religioso, costituito da coloro che Capitini chiamava i “persuasi”, persone che in qualche modo sentivano di dover andare più a fondo, per le quali la piazza non bastava, che sentivano il bisogno di aggiunger qualcosa all’impegno sociale e a quello politico: quella che lui chiamava “l’aggiunta religiosa all’opposizione”. L’aggiunta di chi sente la propria vita appartenere a qualcosa di cui la natura e la specie umana sono solo una parte.
C’è da dire, per non rischiare di idealizzare quella stagione, che intuizioni importanti come quelle che provenivano dalla migliore riflessione pedagogica e sociologica di quegli anni non vennero sempre applicate nel modo migliore e il lavoro di gruppo e lo sviluppo dal basso divennero in alcuni casi e sempre più frequentemente col passare del tempo, formule quasi sacre che rischiavano una fiducia eccessiva nelle virtù che provenivano dal basso (il basso produce anche comportamenti tutt’altro che edificanti e comunitari) e preparavano il terreno a parodie della democrazia. Forme apparenti di iper-democrazia che diventavano il suo esatto opposto. Su queste forme di partecipazione io credo si debba stare molto attenti. La democrazia ha mostrato che i germi della sua corruzione nascono al suo stesso interno fino a farla diventare quella dittatura delle maggioranze manipolate che è sotto gli occhi di tutti.
Ricordo a questo proposito un incontro cui assistetti alla Banca d’Italia, al seguito di Danilo Dolci che cercava finanziamenti per il suo lavoro in Sicilia, con Federico Caffè, grande economista democratico che a un certo punto sparì improvvisamente dalla scena, non si seppe mai se per un suicidio o semplicemente per abbandonare una vita e una carriera che dovevano stargli molto strette. Seguendo un argomento che giustamente spendeva al meglio, anche in quell’occasione Dolci esaltò il lavoro di comunità e dal basso che stava faticosamente portando avanti in alcune delle aree più depresse della Sicilia. Ricordo che con la vena di distaccata ironia che lo caratterizzava, alla fine dell’incontro, il grande economista ci consigliò un romanzo che aveva letto da poco: L’uomo dal vestito grigio (lo ha ristampato qualche anno fa Einaudi). Io ovviamente lo cercai subito e vi trovai tra le altre cose una descrizione dell’aspetto conformista e oppressivo della democrazia all’interno di una piccola comunità americana. Le estenuanti “riunioni delle signore” diventavano una forma di controllo repressivo di comportamenti che, all’interno della comunità, non erano ritenuti normali, un aspetto determinante del controllo sociale sulla libertà dei singoli.
[…] Il discorso sul metodo consegue anche da tutto ciò. E paradossalmente il metodo acquista più valore oggi in cui esso rappresenta uno dei pochi motori della cooperazione e del ben fare. Se negli anni Cinquanta la spinta vera, più che dal metodo, proveniva dal disastro che avevamo alle spalle e dalla speranza che ci si apriva davanti, dal bisogno di ricostruire ciò che fisicamente e culturalmente era stato raso al suolo, e dalla certezza che c’erano le condizioni per farlo, oggi in un momento in cui il futuro ci pare molto più incerto e cupo e quasi certo un suo costante peggioramento, come possiamo storicamente verificare, il metodo assume una fondamentale funzione di vettore, non deterministico, dell’azione pedagogica. Non ci sono più, per fortuna, palingenesi e progetti di rivolgimenti politici in grado di motivare l’agire educativo, anche se dobbiamo aver ferma la necessità di proporre “contenuti” adeguati, un “progetto” complessivo e non astratto di società. L’attenzione al metodo, se non subisce lo stesso destino di assolutizzazione che hanno quasi sempre assunto i contenuti, deve sostituire quella proiezione positiva in un lontano futuro che ha rappresentato per decenni il movente fondamentale delle azioni e giustificazioni educative.
Questo intervento è tratto da Come partorire un mammut (e non rimanere schiacciati sotto), a cura di Giovanni Zoppoli, edito da Marotta&Cafiero nel 2011.
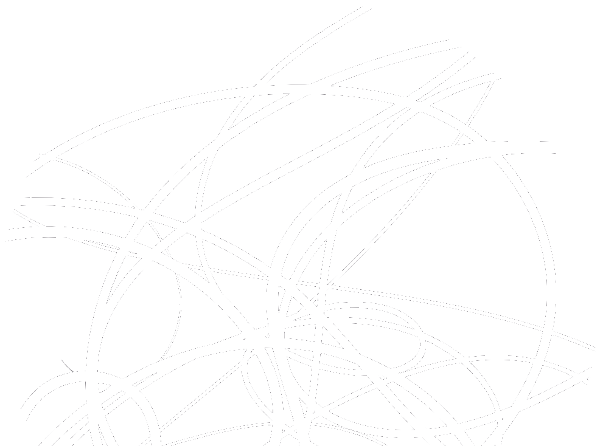

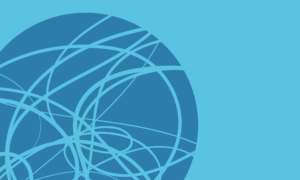


Pingback: Angela Zucconi e il lavoro di comunità - Le strade del mondo